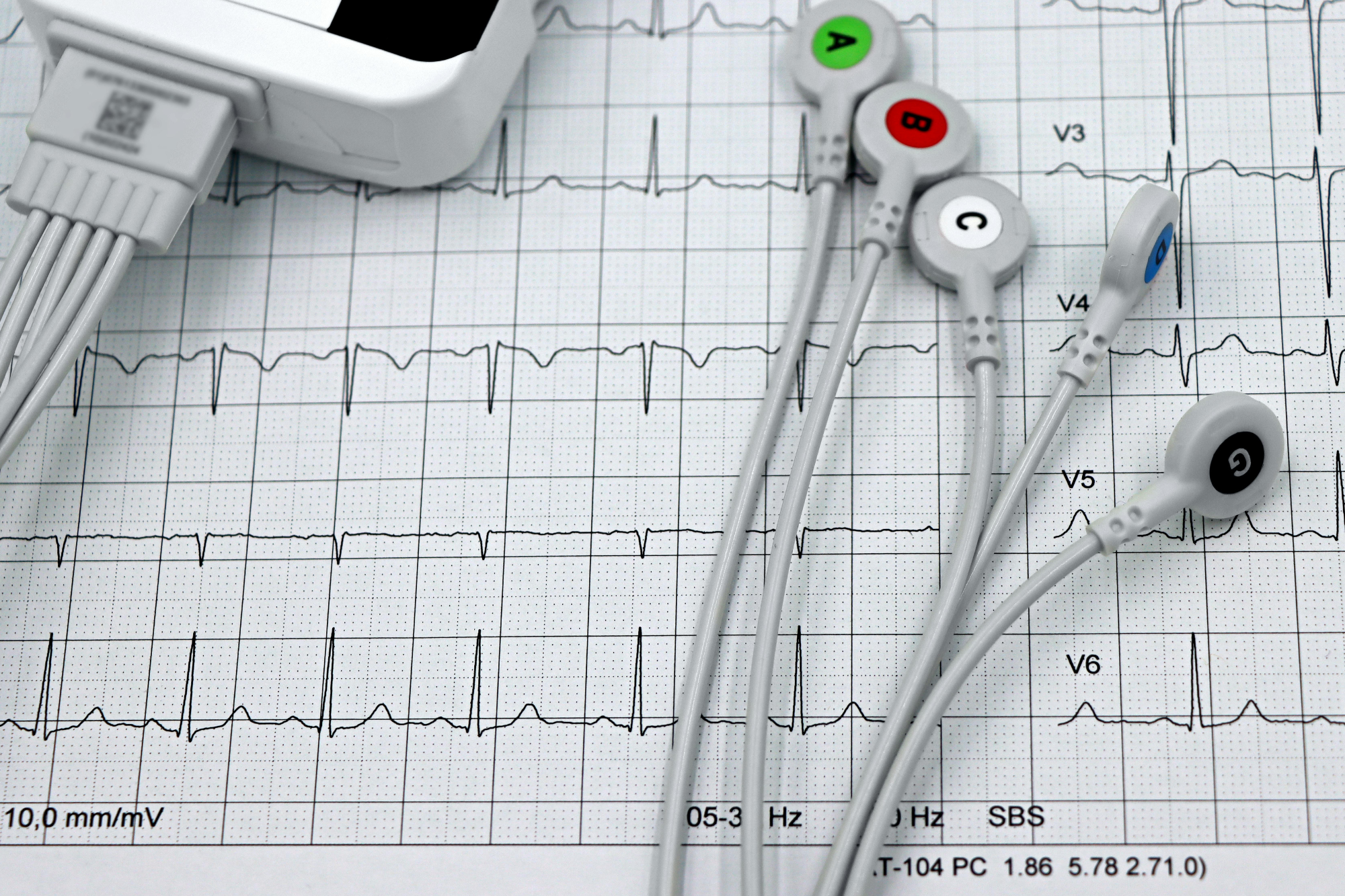Ogni anno in Europa oltre un milione e settecentomila persone muoiono per malattie cardiovascolari. È la prima causa di morte nel continente, un peso che vale un terzo di tutti i decessi. Secondo il nuovo rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente (EEA), quasi un quinto di questi casi non dipende da genetica o abitudini individuali, ma da fattori ambientali modificabili.
Aria inquinata, temperature estreme, rumore e sostanze chimiche tossiche si combinano in una pressione costante sul sistema cardiovascolare. Gli esperti parlano di una pandemia “non infettiva” che può essere contenuta solo con politiche pubbliche strutturali. L’Europa, avverte il rapporto, “ha già dimostrato che agire sull’ambiente salva vite umane: ora serve coerenza”.
1. L’aria che affatica il cuore
L’inquinamento atmosferico è il primo nemico ambientale del cuore europeo. L’EEA stima che l’8% dei decessi cardiovascolari sia legato all’esposizione cronica a polveri sottili (PM2.5), biossido di azoto e ozono. Le particelle più fini penetrano nei polmoni, entrano nel sangue e innescano infiammazioni e stress ossidativo che indeboliscono le pareti vascolari.
In Europa, il particolato fine causa da solo oltre 130 mila morti per infarto e ictus ogni anno e un milione di anni di vita persi.
Non tutti respirano la stessa aria. L’impatto ambientale varia quasi del doppio fra Paesi del Nord e dell’Est. Bulgaria e Polonia superano il 23% dei decessi cardiovascolari associati a fattori ambientali; Croazia e Grecia restano oltre il 22%; l’Italia, con 21,17%, è nella fascia alta europea, penalizzata dalla densità urbana e dall’inquinamento cronico della Pianura Padana. All’estremo opposto, i Paesi scandinavi segnano livelli molto più bassi: Finlandia 9,72%, Svezia 10,01%, Estonia 12,94%.

Nonostante decenni di politiche di riduzione, il 95% dei cittadini europei vive ancora in aree con livelli di inquinamento superiori ai limiti OMS. Il nuovo regolamento europeo sulla qualità dell’aria (Direttiva 2024/2881) punta ad allineare gli standard continentali alle soglie più restrittive dell’Organizzazione mondiale della sanità entro il 2030. L’obiettivo del Piano per l’inquinamento zero è tagliare del 55% le morti premature legate all’aria rispetto al 2005.
Ma la sfida non è solo tecnica: riguarda la capacità degli Stati di imporre controlli reali, sanzioni e investimenti nelle aree più esposte, dove salute pubblica e disuguaglianze sociali coincidono.
2. Il clima come nuovo fattore di rischio
Caldo e freddo estremi stanno ridisegnando la geografia della salute europea. L’EEA stima che oltre 115 mila morti cardiache all’anno siano legate a temperature estreme. Il caldo aumenta la viscosità del sangue e la frequenza cardiaca, il freddo restringe i vasi e alza la pressione: due estremi che mettono a rischio soprattutto anziani e soggetti già fragili.
Le ondate di calore del 2025, tra le più intense mai registrate, hanno provocato un picco di ricoveri per infarto e aritmie pari al +16% rispetto alle medie stagionali. Nelle aree urbane, l’effetto “isola di calore” moltiplica i rischi.
Il fenomeno si intreccia con un’altra emergenza: la povertà energetica. Quasi un cittadino europeo su cinque non riesce a mantenere la casa fresca d’estate, e circa il 9% non riesce a riscaldarla d’inverno. L’incapacità di regolare la temperatura domestica amplifica il rischio cardiovascolare, specialmente tra gli anziani.
Il clima porta con sé anche effetti indiretti. Le ondate di calore favoriscono la formazione di ozono a livello del suolo, mentre gli incendi — oltre un milione di ettari bruciati in Europa nel 2025 — rilasciano particolato e sostanze irritanti che peggiorano la circolazione sanguigna. Persino i soccorritori ne subiscono le conseguenze: l’infarto è la seconda causa di morte tra i vigili del fuoco dopo l’asfissia.
La Commissione europea ha chiesto ai Paesi membri di includere la salute cardiovascolare nei piani di adattamento climatico: venti Stati lo hanno già fatto, ma i sistemi di allerta precoce restano frammentati. L’EEA chiede un coordinamento europeo e la formazione del personale sanitario sui rischi climatici. “I cambiamenti del clima — sottolinea il rapporto — sono già una questione di salute cardiaca”.
3. Il rumore che logora le arterie
È una forma di inquinamento spesso ignorata, ma il rumore urbano provoca decine di migliaia di decessi ogni anno in Europa. L’esposizione cronica a suoni di alta intensità — da traffico, treni e aerei — attiva ormoni dello stress come cortisolo e adrenalina, altera il sonno e fa salire la pressione arteriosa.
Secondo le stime più recenti, 66 mila morti premature nell’Unione sono attribuibili al rumore ambientale, più di un terzo per cause cardiovascolari. Si aggiungono circa 50 mila nuovi casi di malattie cardiache ogni anno correlati al rumore da trasporto.
L’Europa aveva fissato un obiettivo chiaro: ridurre del 30% entro il 2030 la popolazione cronicamente disturbata dai rumori. L’EEA riconosce però che i progressi sono minimi. Dal 2012 l’esposizione media non è diminuita.
Alcune città hanno iniziato a reagire. Parigi e Barcellona stanno riducendo la velocità notturna e aumentando le zone pedonali; Amsterdam ha introdotto aree “quiet zones” vicino a scuole e ospedali; Berlino sperimenta asfalti fonoassorbenti e corridoi verdi che abbattono sia il rumore sia le polveri.
Dal momento che il rumore è un determinante di salute pubblica gli esperti dell’EEA chiedono di trattarlo “come una sostanza tossica: ridurre l’esposizione è l’unica cura efficace”.
4. Le sostanze chimiche e il cuore invisibile
C’è un’Europa che respira male, un’altra che dorme male, e una terza che vive immersa in composti chimici di cui conosce poco gli effetti. L’EEA stima che tra il 2 e il 4% dei decessi cardiovascolari sia collegato all’esposizione cronica a metalli pesanti come piombo, arsenico e mercurio. Anche a livelli considerati “bassi”, queste sostanze alterano la regolazione della pressione sanguigna e favoriscono infiammazioni dei vasi.
Ma non sono solo i metalli. Gli interferenti endocrini, come il DEHP — un ftalato usato in molti prodotti plastici —, sono associati a oltre 27 mila morti cardiovascolari l’anno nella fascia 55–64 anni. A questi si aggiungono i PFAS, i “forever chemicals” che persistono nel suolo e nel sangue umano, con crescenti evidenze di legami con ipertensione e disfunzioni metaboliche.
L’Europa ha già messo in campo strumenti normativi: il Regolamento REACH per la gestione delle sostanze chimiche, la Strategia per la sostenibilità chimica, le nuove regole su pesticidi e acque potabili. I risultati sono reali — le concentrazioni di piombo nel sangue sono scese — ma i livelli restano lontani da quelli considerati sicuri.
Il rapporto dell’EEA chiede un salto di scala. Servono più controlli, incentivi alla sostituzione delle sostanze cardiotossiche e ricerca su metodi di test specifici per gli effetti cardiovascolari, oggi quasi assenti. Cruciale anche la formazione sanitaria: tre quarti delle scuole di medicina europee non includono ancora moduli dedicati a ambiente e salute.
Bruxelles lavora a un piano europeo per la salute cardiovascolare che integrerà i fattori ambientali nelle politiche sanitarie. È un tassello della visione One Health, che mette in relazione la salute umana, quella degli ecosistemi e degli animali. Perché, come ricorda l’EEA, “la prevenzione delle malattie del cuore comincia molto prima del pronto soccorso: nell’aria che respiriamo, nelle case in cui viviamo, nelle sostanze che ogni giorno tocchiamo senza vederle”.