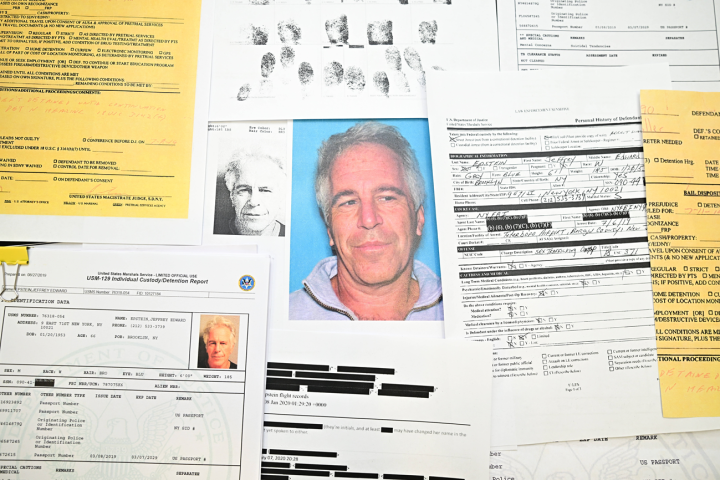A Bruxelles è tornato il lessico della serietà. L’Unione europea non promette più un ingresso automatico a chi bussa alle sue porte: pretende prove, risultati e garanzie. “I futuri trattati di adesione dovranno contenere garanzie più forti, pur mantenendo il principio fondamentale di uguaglianza”, ha scandito la commissaria Marta Kos davanti alla commissione Afet del Parlamento europeo. È una frase che segna il cambio di passo. Dopo anni di stasi e di diplomazia cauto-inclusiva, la Commissione parla di “qualità delle riforme” e di “massima integrità dell’Unione”. Non più slancio idealistico, ma controllo. Non più una promessa geopolitica, ma un test di affidabilità.
Nel linguaggio tecnico di Bruxelles si chiama “pre-allargamento”, ma la sostanza è una ridefinizione del patto politico interno. Kos insiste sul fatto che “ogni precedente allargamento ha reso l’Unione più forte”, ma riconosce anche che oggi serve un sistema di salvaguardie che impedisca regressioni democratiche. La memoria è fresca: la lunga stagione di attriti con Polonia e Ungheria ha lasciato cicatrici che nessuno vuole riaprire. Così il nuovo corso sposta l’attenzione dall’adesione al consolidamento. “Tutto è possibile — ha ammesso la commissaria — dai periodi di transizione a forme specifiche di controllo, ma non ci saranno Stati membri di serie A e serie B”.
Nel frattempo, l’Alta rappresentante Kaja Kallas rilancia la sfida della capacità decisionale: “Se vogliamo essere una potenza geopolitica, dobbiamo saper decidere”. Il sottotesto è evidente: l’allargamento non sarà sostenibile senza una revisione del sistema interno di voto e governance. L’Unione guarda quindi all’espansione con un doppio binocolo — integrazione esterna e riforma interna — e rimette in discussione il proprio equilibrio di potere.
L’Ucraina corre, l’Europa frena
L’Ucraina corre contro il calendario e contro la guerra. Vuole chiudere i negoziati entro il 2028, e la Commissione accetta la sfida, ma fissa condizioni che suonano come un ultimatum politico: “Per raggiungere l’obiettivo serve un’accelerazione del ritmo delle riforme, in particolare sullo Stato di diritto”. Il messaggio è diretto a Kiev, ma parla a tutta l’Unione. La posta in gioco non è solo l’ingresso di un Paese: è la capacità dell’Europa di restare credibile mentre combatte una guerra per procura ai suoi confini.
L’esecutivo comunitario riconosce che Kiev “ha completato con successo lo screening” e ha adottato “tabelle di marcia” su giustizia e amministrazione, ma mette in guardia: i progressi rischiano di essere vanificati da “pressioni sulle agenzie anticorruzione e sulla società civile”. Il sostegno politico non vacilla, ma la pazienza tecnica sì. L’apertura di tre cluster negoziali su sei è un risultato, ma resta sospesa sul veto ungherese, che blocca l’avvio formale dei colloqui. Il presidente Zelensky, da Bruxelles, ha lanciato un appello diretto a Viktor Orbán: “Saremmo contenti se ci sostenesse o, almeno, non ci bloccasse”.
La Moldova procede in parallelo, ma con meno ostacoli e più disciplina amministrativa. Chisinau punta a chiudere provvisoriamente i negoziati all’inizio del 2028, sostenuta da un Parlamento coeso e da una presidente, Maia Sandu, che ha trasformato l’europeismo in agenda di governo. La Commissione ne riconosce i progressi: “Ha completato con successo lo screening anche a fronte di minacce ibride e tentativi di destabilizzazione”. Il primo vertice Ue-Moldova del luglio 2025 è stato il simbolo di una cooperazione che si consolida. Per Bruxelles, il tandem Kiev-Chisinau è la nuova frontiera politica dell’Unione: una linea di difesa e, allo stesso tempo, di espansione. Ma il tempo lavora in direzione contraria: ogni mese di guerra riduce lo spazio per la diplomazia e mette alla prova la coerenza europea.
I Balcani e il test di credibilità dell’Unione
Podgorica e Tirana hanno conquistato il ruolo di “primi della classe” del nuovo allargamento. Il Montenegro potrebbe chiudere i negoziati entro il 2026, l’Albania entro il 2027. Due Paesi piccoli, ma con una funzione simbolica: dimostrare che il processo funziona se le riforme sono reali. Bruxelles parla di “progressi significativi”, riconoscendo al Montenegro la chiusura di quattro capitoli negoziali in un anno e un “chiaro impegno politico” verso l’integrazione. Per l’Albania, la Commissione parla di “slancio senza precedenti”, con quattro cluster aperti e l’ultimo in preparazione. Ma dietro i numeri restano i nodi strutturali: lotta alla corruzione, libertà di stampa, criminalità organizzata.
La logica dell’allargamento si sposta così dal consenso politico al merito tecnico. “È un processo complesso ma basato sui risultati”, ripete l’Alta rappresentante Kallas. Tradotto: niente scorciatoie. Il messaggio è rivolto anche a Belgrado, che da anni alterna promesse europee e vicinanza a Mosca. Nel rapporto 2025 la Commissione parla di “notevole rallentamento delle riforme” e denuncia “retoriche divisive e narrazioni anti-Ue”. È il linguaggio di chi non intende più concedere indulgenze geopolitiche. La Serbia, insieme alla Bosnia-Erzegovina, resta bloccata nella spirale delle proprie crisi interne: la prima sospesa tra l’attrazione russa e la dipendenza economica europea, la seconda paralizzata dalla deriva secessionista della Republika Srpska.
Il nuovo pacchetto sull’allargamento fotografa un’area balcanica spaccata in due: da un lato i Paesi che hanno scelto la disciplina europea, dall’altro quelli che continuano a usarla come moneta politica interna.
Le porte chiuse del fronte orientale
Se l’Est e i Balcani mostrano dinamiche divergenti ma vitali, la Georgia rappresenta il fallimento di un’intera strategia. “La Commissione considera la Georgia un Paese candidato solo di nome”, si legge nel pacchetto annuale. Il governo del partito Sogno Georgiano ha ribaltato anni di progressi con una legislazione repressiva e un arretramento democratico definito “drastico”. Bruxelles denuncia la “rapida erosione dello Stato di diritto” e “gravi restrizioni ai diritti fondamentali”, dalla libertà di espressione al principio di non discriminazione. In altre parole, un crollo politico che rende il Paese un caso-limite: candidato sulla carta, ma escluso nei fatti.
Dietro la severità del giudizio c’è la preoccupazione per l’influenza russa e per l’effetto domino su altri aspiranti membri. La Commissione invita Tbilisi a “invertire urgentemente la rotta” e a “ritornare al percorso di adesione”, ma per ora le parole restano senza risposta.
Non va meglio alla Turchia, ormai da anni sospesa in una zona grigia tra alleanza e distanza. “I fatti che hanno portato a congelare il processo di integrazione rimangono invariati”, si legge nel rapporto. Tradotto: nessun passo avanti su diritti fondamentali e Stato di diritto, mentre l’apparato politico di Ankara continua a considerare l’Ue più come un interlocutore economico che come un orizzonte politico. Tuttavia, la Commissione riconosce che “le sfide geopolitiche rendono necessario un partenariato più forte”.
Ursula von der Leyen, nel commentare la relazione, ha sintetizzato la filosofia del momento: “Siamo più che mai impegnati a trasformare l’allargamento in realtà. Ma deve restare un processo basato sul merito”. Niente romanticismo, dunque.