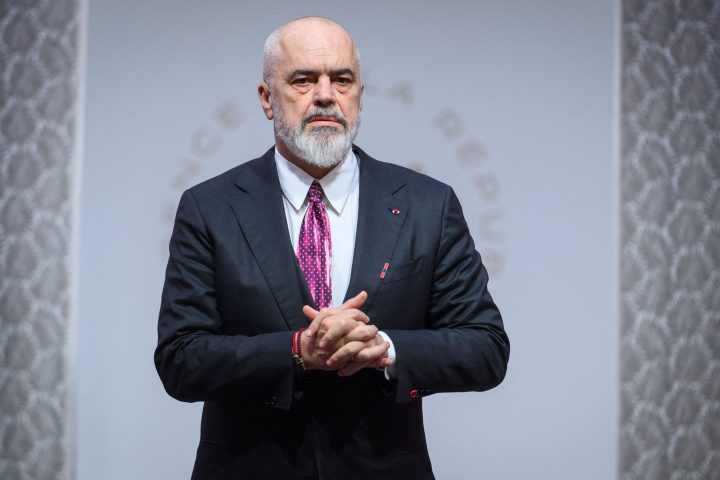L’Italia rilancia in Europa una battaglia educativa e culturale destinata a segnare una svolta nel rapporto tra istruzione e tecnologia. Il 12 maggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara presenterà alla Commissione europea una richiesta formale per una raccomandazione che vieti l’uso degli smartphone in classe per gli studenti al di sotto dei 14 anni. L’iniziativa – sostenuta da Polonia e Svezia – si inserisce nel più ampio dibattito continentale sull’impatto del digitale nel contesto scolastico e sulla necessità di salvaguardare salute mentale, rendimento cognitivo e relazioni interpersonali dei più giovani.
Il provvedimento, ispirato al principio di precauzione, nasce dalla crescente consapevolezza scientifica sui danni legati all’eccessiva esposizione agli schermi in età evolutiva. Il dibattito, già acceso nei singoli Stati membri, si sposta ora sul piano sovranazionale, dove l’Italia intende farsi capofila di una strategia comune in materia di educazione digitale. Un passaggio che chiama in causa il ruolo dell’Unione europea nel sostenere politiche pubbliche attente al benessere delle nuove generazioni.
Smartphone e minori: l’Italia chiede una svolta comune in sede Ue
“È un’iniziativa molto importante – ha dichiarato Valditara –. Ne avevamo già parlato informalmente nelle riunioni a Bruxelles e a gennaio l’avevo proposta alla Presidenza polacca”. L’intenzione, ha spiegato, è quella di portare avanti una richiesta di raccomandazione che impegni gli Stati membri dell’Unione Europea a vietare l’uso dei cellulari nelle scuole almeno fino ai 14 anni. L’obiettivo non è solo limitare la presenza fisica degli smartphone, ma affermare un principio pedagogico: a scuola si va per apprendere, relazionarsi, crescere, non per essere continuamente interrotti da notifiche, chat o video virali.
La proposta non mira a sostituire l’autonomia didattica dei singoli istituti, né pretende di normare in modo uniforme realtà educative molto diverse tra loro. Si configura invece come un invito forte e motivato a tutti gli Stati membri a dotarsi di una cornice comune, basata sulle evidenze scientifiche e sull’urgenza educativa. L’uso eccessivo di dispositivi digitali, ha ricordato il ministro, “ha un impatto fortemente negativo sulla capacità di concentrazione, sulla memoria, sulla fantasia e sullo sviluppo cognitivo dei nostri ragazzi”. Per questo l’iniziativa punta a un cambio di paradigma culturale, non solo a un regolamento tecnico.
Nel quadro normativo europeo, le raccomandazioni non sono vincolanti, ma rappresentano uno strumento fondamentale per orientare le politiche nazionali. La richiesta italiana, se accolta dalla Commissione, sarà sottoposta alla valutazione degli Stati membri e, successivamente, ai ministri dell’Istruzione in sede di Consiglio. Il sostegno espresso da Polonia e Svezia segnala che esiste già un asse favorevole a questa visione, che potrebbe trovare sponde anche in altri paesi del Nord e Centro Europa, tradizionalmente più inclini a politiche scolastiche preventive e strutturate in ambito digitale.
Le politiche europee in materia di smartphone a scuola
Se la proposta italiana appare oggi pionieristica sul piano comunitario, molti Stati membri hanno già introdotto misure nazionali per regolamentare l’uso degli smartphone in ambito scolastico. In prima linea c’è la Francia, che dal 2018 vieta l’uso dei telefoni cellulari nelle scuole primarie e secondarie. Recentemente, Parigi ha rafforzato il divieto estendendolo a circa 200 scuole attraverso un progetto sperimentale di “interruzione digitale” che coinvolge 50mila studenti. L’obiettivo non è solo ridurre la distrazione in classe, ma anche ristabilire un rapporto sano tra alunni, insegnanti e ambiente scolastico, eliminando una fonte pervasiva di ansia e isolamento.
Anche la Finlandia, spesso citata come modello educativo in Europa, ha deciso di intervenire in modo deciso. Una nuova legge, entrata in vigore lo scorso mese di aprile, attribuirà maggiori poteri ai dirigenti scolastici per vietare l’uso dei dispositivi mobili durante le ore di lezione. I telefoni potranno essere utilizzati solo previa autorizzazione e per motivi didattici o di salute. Una misura che si aggiunge a una tradizione già consolidata di attenzione al benessere psicofisico degli studenti, considerato parte integrante dell’apprendimento.
In Olanda, dal gennaio 2024 è in vigore un divieto di utilizzo “non educativo” degli smartphone nelle scuole primarie e secondarie. Il provvedimento include anche tablet e smartwatch e prevede eccezioni solo per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. L’Ungheria, dal canto suo, ha adottato un divieto simile a partire da settembre 2024, non senza polemiche da parte dei sindacati degli insegnanti. In Spagna, dove le politiche scolastiche sono gestite a livello regionale, circa sette comunità autonome hanno introdotto restrizioni importanti. L’Irlanda, infine, ha investito nove milioni di euro per dotare gli istituti di appositi contenitori sicuri in cui riporre i telefoni per tutta la giornata scolastica.
L’ampiezza e la varietà di queste iniziative dimostrano che la questione dell’uso degli smartphone a scuola è già percepita come una priorità in molti paesi europei. Tuttavia, l’assenza di una linea comune a livello Ue genera disparità nella tutela degli studenti e nella gestione delle dinamiche scolastiche. In questo contesto, la proposta italiana assume un valore strategico, configurandosi come tentativo di armonizzare le politiche educative europee nel segno della responsabilità condivisa.
C’è da dire che il Parlamento europeo aveva già avviato un dibattito sull’uso degli smartphone nelle scuole, con particolare attenzione agli studenti di età compresa tra 6 e 15 anni, con i deputati del gruppo dei Verdi in prima linea che avevano sollecitato la Commissione europea a considerare misure restrittive. Glenn Micallef, commissario europeo per l’Istruzione e la gioventù, ha dichiarato che la Commissione sta raccogliendo dati e pratiche da tutta l’Ue sull’impatto dei divieti di telefonia mobile nelle scuole, con l’obiettivo di prendere una decisione entro la fine del 2025.
Il costo dell’abuso digitale
L’abuso degli smartphone in età scolare è oggetto di una crescente mole di ricerche che ne evidenziano i molteplici effetti negativi sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei minori. Secondo gli esperti, la presenza costante del telefono in classe – anche se non direttamente utilizzato – può compromettere l’attenzione selettiva, ridurre la capacità di elaborazione delle informazioni e ostacolare la memorizzazione a lungo termine. È il cosiddetto “effetto distrazione latente”, per cui il solo sapere di avere il dispositivo a portata di mano genera un carico cognitivo aggiuntivo che interferisce con il processo di apprendimento.
Le implicazioni, tuttavia, non si limitano alla sfera cognitiva. Numerosi studi internazionali, pubblicati su riviste accademiche come The Lancet Child & Adolescent Health e Jama Pediatrics, collegano l’uso prolungato e non regolato dei dispositivi digitali a un aumento dei sintomi depressivi, disturbi d’ansia, difficoltà nel sonno e dipendenza comportamentale. L’allarme è stato rilanciato anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, che ha posto l’attenzione sul ruolo dei genitori: “La dipendenza dal digitale può danneggiare i bambini anche quando a esserne colpiti sono i loro genitori”.
Secondo Terragni, è necessaria una presa di coscienza collettiva. Nove italiani su dieci non lasciano passare un’ora senza controllare lo smartphone e il tempo medio trascorso online supera le cinque ore e mezza al giorno. Un dato allarmante che non solo riguarda gli adolescenti, ma investe l’intera struttura educativa, familiare e scolastica. Il mancato “aggancio oculare” nei primi mesi di vita, fondamentale per lo sviluppo del linguaggio e della relazione, può essere compromesso da un modello relazionale dominato dallo schermo. In questo quadro, la scuola può e deve proporsi come presidio di educazione alla disconnessione: uno spazio in cui la sospensione tecnologica diventa occasione di crescita, riflessione e riequilibrio.