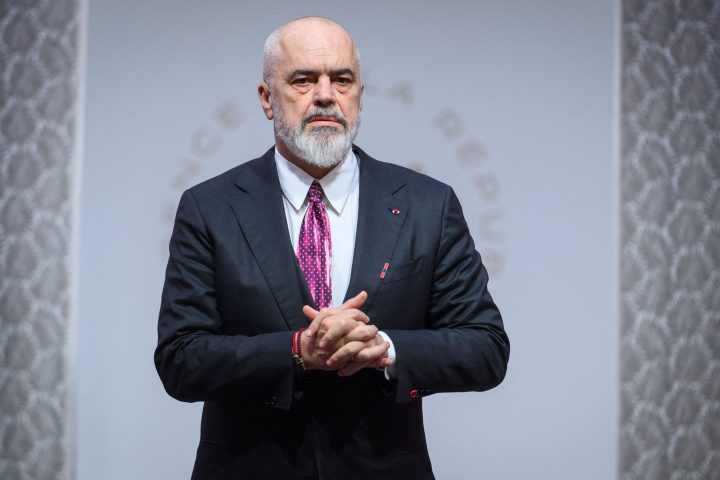Sconvolgente è il potere che una singola parola può esercitare: un’esplosione di significati, di emozioni, di storia e di cultura racchiusi in pochi suoni. Nell’Europa di oggi, dove il multilinguismo non è solo una caratteristica, ma una linfa vitale, termini come lagom, saudade, załatwić, dépaysement e l’italiana meriggiare – resa celebre da Montale – rappresentano autentici ponti verso mondi altrimenti inaccessibili. Questa ricchezza linguistica, che travalica i confini e abbatte le barriere culturali, si manifesta quotidianamente in una terra che vanta 24 lingue ufficiali e ben 60 lingue regionali o minoritarie, parlate da oltre 40 milioni di europei. Ogni lingua, con le sue sfumature, i suoi ritmi e le sue peculiarità, ci invita a scoprire una prospettiva unica sulla vita e sul mondo. Un viaggio linguistico che è il cuore pulsante di ciò che celebriamo oggi con la Giornata Internazionale della Lingua Madre: la bellezza e la fragilità di un patrimonio che corre il rischio di svanire, ma che può essere preservato attraverso l’impegno delle nuove generazioni.
In un continente dove ogni cittadino, pur parlando una lingua diversa, può condividere storie, tradizioni e visioni del futuro, il concetto di lagom – quella ricerca del giusto equilibrio, della misura perfetta – si trasforma in un ideale collettivo. Non si tratta di un mero termine svedese, ma di un invito a vivere in sintonia con se stessi e con gli altri, evitando eccessi e spingendosi, al contempo, a riconoscere la ricchezza insita in ogni diversità. Allo stesso modo, la parola portoghese saudade racchiude in sé una malinconia dolceamara, un desiderio profondo e spesso inspiegabile, che sfugge alle traduzioni letterali e testimonia l’intrinseco legame tra lingua e identità culturale. Questa capacità di esprimere emozioni in modo unico non è soltanto un privilegio linguistico, ma rappresenta il fondamento stesso dell’essere umano: la capacità di comunicare, di comprendere e di riconoscere l’altro.
Nel cuore dell’Europa, dove le migrazioni e le interazioni quotidiane hanno fatto della diversità una forza, esiste anche la parola polacca załatwić, che va ben oltre il semplice “risolvere”: implica un’azione decisa, pragmatica, una volontà di mettere in ordine il caos della quotidianità. E poi c’è il francese dépaysement, una parola che evoca il senso di estraneità e la meraviglia del trovarsi in un ambiente che, pur essendo vicino, sa sorprendere e trasformare. In questo scenario, l’Europa si erge come un laboratorio vivente, dove il dialogo interculturale non è solo auspicabile, ma indispensabile per la convivenza pacifica e il progresso sociale. È un invito a meriggiare, a fermarsi un attimo come suggeriva Eugenio Montale, e a godere del silenzio carico di significato che solo la contemplazione di un retaggio linguistico millenario sa donare.
Queste parole, intraducibili nella loro completezza, rappresentano il patrimonio immateriale di un continente che si nutre di diversità.
La minaccia della globalizzazione sulle lingue minoritarie
Oggi, nel vortice incessante della globalizzazione, la ricchezza delle lingue minoritarie rischia di essere inghiottita da un’ondata di uniformità culturale e comunicativa. Ogni due settimane, si spegne una lingua, e con essa scompare un intero patrimonio di conoscenze, tradizioni e visioni del mondo. Le stime dell’Unesco parlano di 8.324 lingue parlate o firmate nel mondo, ma la realtà è ben più drammatica: quasi il 40% della popolazione globale non ha accesso all’educazione nella propria lingua madre, una condizione che rischia di far scomparire quelle radici culturali che da secoli hanno definito l’identità di intere comunità.
In Europa, il fenomeno è altrettanto preoccupante. Le lingue regionali e minoritarie, spesso trasmesse oralmente e custodite gelosamente dalle comunità locali, sono esposte al rischio di un progressivo appiattimento, favorito dalla predominanza di lingue globali come l’inglese, il francese o il tedesco. La mancanza di adeguati supporti educativi e mediatici, unita al fascino irresistibile di un’economia sempre più globalizzata, spinge i giovani a relegare in secondo piano il valore della propria lingua di origine. Il risultato? Una perdita irreparabile di identità e di cultura, una scomparsa che si ripercuote non solo sul tessuto sociale, ma anche sulla capacità delle comunità di raccontare la propria storia e di trasmettere il proprio sapere alle future generazioni.
Questa dinamica è particolarmente evidente in contesti in cui la lingua è molto più di uno strumento di comunicazione: essa è il custode delle emozioni, dei riti e delle tradizioni che hanno caratterizzato la vita di un popolo. La difficoltà di trasmettere l’essenza di questi termini sottolinea l’urgenza di preservare un patrimonio linguistico che rischia di essere cancellato dall’omogeneizzazione culturale. Se da un lato la globalizzazione promette opportunità e connessioni, dall’altro essa impone una scelta: quella di abbracciare la modernità senza rinunciare alle radici, di investire nelle lingue minoritarie affinché possano continuare a fiorire in un mondo che, troppo spesso, sembra incapace di apprezzare la bellezza del dettaglio e della diversità.
In questo scenario, le istituzioni europee si trovano a dover conciliare l’inevitabile progresso tecnologico e la standardizzazione globale con la necessità di tutelare una pluralità di espressioni linguistiche. È un compito arduo, che richiede visioni lungimiranti e politiche educative inclusive, capaci di restituire valore a quei termini che, pur essendo intraducibili, sono fondamentali per la costruzione di un’identità condivisa. La sfida è quella di far sì che ogni bambino, indipendentemente dal luogo in cui nasce, possa meriggiare – in senso letterale e figurato – nel calore della propria lingua madre, trovando in essa non solo un mezzo di comunicazione, ma un ponte verso la propria storia e un bagliore di speranza per il futuro.