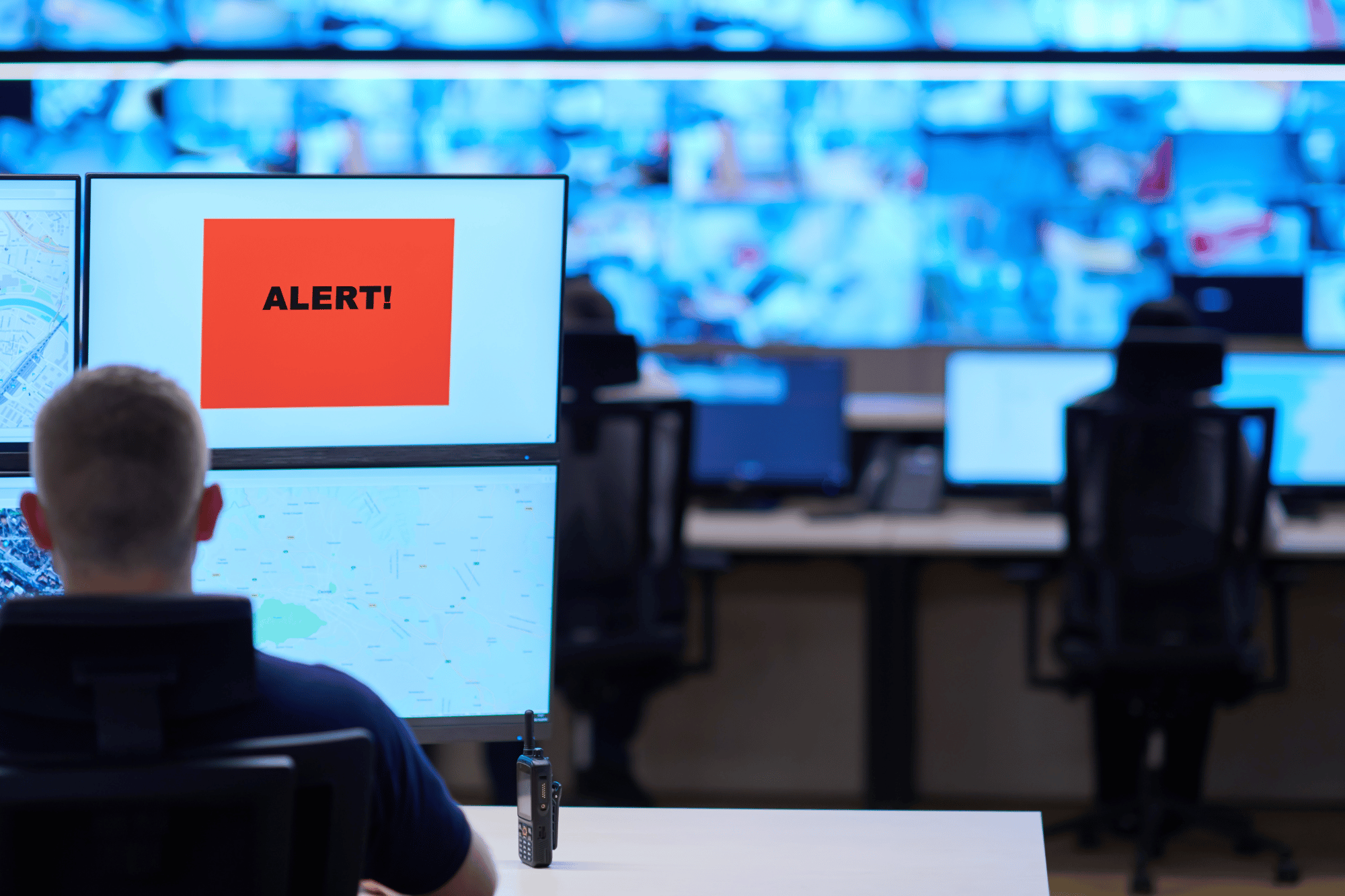L’intreccio di attacchi cyber, interferenze energetiche, operazioni informative e campagne di influenza statuale sta modificando il terreno su cui si gioca la sicurezza dell’Italia. La sequenza di eventi che ha portato alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa del 17 novembre e alla diffusione del non-paper del ministro Guido Crosetto è la risposta a iniziative ostili che ormai condizionano direttamente la vita pubblica. Non sono episodi isolati, ma una pressione costante che investe politica, economia e comunicazione. Il Paese deve reagire con un livello di integrazione tra vertici istituzionali, apparati militari e strutture civili che non ha precedenti nella storia recente.
La crescente esposizione italiana supera la dimensione tecnologica. È lo spazio decisionale ad essere messo in discussione: procedure, percezioni, fiducia. La guerra ibrida agisce dove la frontiera tra sicurezza nazionale e quotidianità diventa sottile, sfruttando vulnerabilità informative, economiche e sociali. Il governo e il Quirinale, con intensità diverse ma con una convergenza evidente, hanno riconosciuto che l’asse del problema non è stabilire se la minaccia esista. La questione è come affrontarla con strumenti adeguati e tempi compatibili con la velocità degli attacchi.
Dove l’Italia è più esposta oggi
Il Consiglio Supremo di Difesa individua un quadro di esposizione articolato, che coinvolge diversi settori strategici. Al primo posto compare la dimensione digitale, descritta come caratterizzata da offensive basate su “velocità, volume e ubiquità” della tecnologia, amplificate dall’uso malevolo dell’Intelligenza artificiale. Questo riferimento indica la possibilità che attacchi simultanei possano sovraccaricare i sistemi, rendendo difficile distinguere eventi accidentali da azioni coordinate.
Una seconda area di vulnerabilità riguarda le infrastrutture critiche, tra cui reti energetiche, trasporti, logistica, servizi finanziari e sistemi sanitari. Il Consiglio segnala il rischio di “interruzioni, ritardi, frizioni e sfiducia sistemica” nel caso di attacchi condotti con tecniche in grado di compromettere funzioni operative fondamentali. La varietà dei settori coinvolti richiede l’integrazione di misure tecniche, regolamentari e organizzative per assicurare continuità e recupero delle attività essenziali.
La dimensione informativa rappresenta una terza vulnerabilità. Il Consiglio descrive la “manipolazione dello spazio cognitivo” come parte integrante della minaccia, indicando campagne di disinformazione, interferenze nei processi democratici e contenuti polarizzanti come strumenti utilizzati per influenzare opinioni e comportamenti. Questa componente non riguarda solo la diffusione di contenuti falsi: include anche l’alterazione dei flussi informativi e il loro utilizzo per generare disordine comunicativo.
A queste vulnerabilità si aggiungono il dominio spaziale e la dimensione subacquea, segnalati come ambiti in cui l’importanza per la sicurezza è “in crescita esponenziale”. Le reti satellitari, i cavi sottomarini e le infrastrutture profonde del Mediterraneo rappresentano asset strategici che richiedono livelli di protezione adeguati alle minacce emergenti.
Il fronte invisibile
Il Consiglio Supremo di Difesa identifica nella manipolazione informativa uno dei principali vettori di rischio. Le attività citate includono la diffusione coordinata di contenuti polarizzanti, l’alterazione di flussi comunicativi e l’inserimento di contenuti progettati per minare la fiducia nelle istituzioni. Secondo il comunicato, tali campagne possono influire sul regolare svolgimento dei processi democratici, attraverso interferenze destinate a modificare la percezione pubblica di eventi e decisioni politiche.
Un elemento rilevante riguarda la difficoltà di attribuzione delle fonti e l’uso crescente di tecniche automatizzate. L’impiego di Intelligenza artificiale nella generazione di contenuti rende più complesso distinguere tra messaggi autentici e materiali creati per influenzare il dibattito. Il Consiglio sottolinea che tali operazioni tendono a sfruttare le piattaforme digitali per amplificare contenuti che possano creare fraintendimenti, divisioni o sospetti verso attori istituzionali.
Il non-paper di Crosetto approfondisce queste dinamiche associandole a possibili attacchi contro infrastrutture e servizi essenziali. Il documento elenca scenari in cui iniziative digitali possono essere combinate con pressioni sui sistemi tecnici, con effetti come blocchi della mobilità, problemi nei servizi finanziari, disservizi nelle strutture sanitarie o compromissioni di banche dati sensibili. Le iniziative di disinformazione vengono quindi trattate come parte di un ecosistema più ampio di minacce, in cui attacchi informativi e attacchi tecnici possono rafforzarsi reciprocamente.
Il documento richiama inoltre la necessità di una risposta proattiva da parte dello Stato. Tra le misure indicate figurano il rafforzamento delle capacità di verifica delle informazioni, l’adozione di strumenti tecnici per la protezione dei processi democratici e la costruzione di meccanismi che possano migliorare la resilienza cognitiva della popolazione, attraverso programmi di formazione e alfabetizzazione digitale.
I teatri esterni che influenzano la sicurezza nazionale
Il Consiglio Supremo di Difesa colloca la minaccia ibrida all’interno di un quadro internazionale caratterizzato da una molteplicità di crisi simultanee, ciascuna con impatti diretti o indiretti sulla sicurezza italiana. L’analisi parte dal conflitto in Ucraina, definito privo di “segnali di distensione”. Il Consiglio sottolinea “l’accanimento della Russia” nel perseguire obiettivi di annessione territoriale e richiama i bombardamenti continui contro infrastrutture critiche e obiettivi civili, con conseguenti interruzioni energetiche e vittime. Il sostegno dell’Italia a Kiev viene ribadito attraverso la conferma degli aiuti militari previsti dal dodicesimo decreto e della partecipazione alle iniziative Ue e Nato.
Un punto specifico riguarda l’impiego dei droni. Il Consiglio osserva che l’utilizzo esteso di questi sistemi da parte della Russia ha introdotto elementi di trasformazione operativa, con episodi di violazione dello spazio aereo della Nato e dell’Unione Europea. La menzione evidenzia l’importanza di adeguare le capacità di difesa alle tecnologie emergenti, in linea con i progetti inseriti nel Libro Bianco per la Difesa 2030, che l’Italia considera parte dell’evoluzione necessaria dello strumento militare europeo.
Sul fronte mediorientale, il Consiglio “valuta positivamente” il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, pur segnalando la “grande preoccupazione” per il continuo verificarsi di episodi di violenza con un alto numero di vittime civili. Viene ribadito che le reazioni ai fatti di Gaza non devono trasformarsi in derive antisemite. Per una soluzione duratura, il Consiglio richiama un “approccio regionale e multilaterale” e considera indispensabile il disarmo di Hamas e il ruolo dell’Autorità Nazionale Palestinese. L’Italia conferma il proprio impegno nella dimensione umanitaria e nella formazione delle forze di polizia palestinesi, insieme alla partecipazione alle iniziative europee.
La situazione nel Sud del Libano viene definita “fragile”, con riferimento a “perduranti violazioni” della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Particolare attenzione è dedicata agli “inaccettabili attacchi” contro il contingente Unifil, attualmente a guida italiana. Il Consiglio indica la necessità di garantire la sicurezza della Linea Blu e richiama le implicazioni della decisione dell’Onu di avviare la conclusione della missione, che richiede un rafforzamento delle Forze Armate libanesi per assicurare stabilità sul terreno.
Il quadro nordafricano e saheliano viene descritto come “area cruciale per la sicurezza del continente europeo”. Il Consiglio richiama la situazione “critica” in Libia e nel Sahel, entrambe caratterizzate da instabilità politica e dalla presenza di attori capaci di esercitare pressioni sulla regione mediterranea. La guerra civile in Sudan viene definita causa di una “gravissima crisi umanitaria” e indicata come fattore di destabilizzazione anche per gli equilibri limitrofi.
Per i Balcani occidentali, il Consiglio rileva la presenza di “alcune forti tensioni bilaterali”, sottolineando che l’Italia rimane impegnata nel sostegno alla stabilità dell’area. Il richiamo alle “presenze ostili nel Mediterraneo” meritevoli di “attenta considerazione anche da parte della Nato” conferma che la sicurezza nazionale non è influenzata soltanto da crisi lontane, ma anche da dinamiche che coinvolgono attori esterni attivi nelle immediate vicinanze strategiche dell’Italia.
Nel complesso, la valutazione del Consiglio delinea un ambiente in cui conflitti armati, instabilità politica e attività ostili non convenzionali si sovrappongono, generando effetti che possono estendersi al territorio italiano mediante pressioni energetiche, flussi migratori, interferenze digitali o iniziative condotte da attori legati a governi ostili. La continuità delle missioni italiane all’estero e il coordinamento con Nato e Unione Europea vengono presentati come elementi indispensabili per contenere tali rischi.
Il non-paper di Crosetto
Il non-paper elaborato dal ministro della Difesa Guido Crosetto definisce in modo esteso la natura della minaccia ibrida che coinvolge l’Italia e propone una serie di interventi mirati a rafforzarne la capacità di protezione. Al centro del documento c’è l’affermazione che la guerra ibrida rappresenti “una guerra continua che ci minaccia senza sosta, giorno e notte”, condotta attraverso attività rivolte contro “infrastrutture critiche, centri decisionali, servizi essenziali, strutture commerciali, industrie, catene di approvvigionamento e il patrimonio cognitivo delle popolazioni”. Il ministro descrive tali attività come costruite da “attori malevoli e privi di scrupoli”, in alcuni casi legati a governi che avrebbero “abbandonato ogni riferimento al diritto internazionale”.
La prima componente del non-paper è una mappatura dettagliata dei possibili effetti degli attacchi ibridi. Tra gli scenari considerati figurano il blocco dei trasporti pubblici, con impatti sulla mobilità ferroviaria e aerea; l’interruzione o il malfunzionamento delle strutture ospedaliere, comprese sale operatorie e reparti di rianimazione; la paralisi del sistema sanitario e dei servizi amministrativi collegati; il collasso dei sistemi bancari; la corruzione o perdita dei dati su cui si basano stipendi, pensioni e altri servizi essenziali. Tali esempi sono presentati come casi realistici in un contesto caratterizzato da strumenti informatici capaci di generare effetti sistemici in tempi ridotti.
Una seconda componente riguarda l’analisi degli attacchi di natura informativa e cognitiva. Il ministro evidenzia che le azioni nel dominio delle informazioni e della guerra cognitiva operano sfruttando l’assenza di reazione da parte degli Stati colpiti. Il documento afferma che gli aggressori dispongono di strumenti capaci di condizionare l’opinione pubblica attraverso campagne di disinformazione, manipolazione coordinata dei contenuti digitali e tecniche basate su Intelligenza artificiale, senza che sia possibile individuare facilmente i responsabili. Da ciò deriva la richiesta di una postura difensiva non solo reattiva ma anche preventiva.
Il non-paper indica quindi quattro direttrici operative.
- La prima è l’aggiornamento del quadro normativo, ritenuto “improcrastinabile”, per consentire alla Difesa di operare con continuità su tutto il perimetro cyber nazionale.
- La seconda è la definizione dello spazio cibernetico di interesse nazionale come “campo di operazioni”, al pari degli spazi terrestre, marittimo e aereo, con regole chiare di responsabilità e intervento.
- La terza direttrice è la costituzione di un’Arma Cyber. Il ministro indica come obiettivo a regime un organico di circa 5.000 unità, articolato su una componente militare e una civile, con capacità operative attive senza interruzioni. In una fase iniziale, viene proposta la creazione di una forza di 1.200–1.500 unità, per il 75% dedicata esclusivamente a compiti operativi, così da garantire un presidio costante, secondo un modello paragonabile a quello già presente nella difesa aerea. Il documento sottolinea la necessità di tutele funzionali adeguate per gli specialisti impiegati in tali attività.
- La quarta direttrice riguarda l’istituzione di un Centro per il Contrasto alla Guerra Ibrida, dotato di funzioni di comando e controllo e di capacità dedicate alla raccolta, all’analisi e alla condivisione rapida di informazioni sulle attività ostili nel dominio cognitivo. Il Centro dovrebbe coordinare la risposta nazionale e favorire lo scambio di pratiche con Paesi alleati.
Una sezione specifica del non-paper è dedicata alla dimensione europea. Il ministro propone che le istituzioni comunitarie assumano un ruolo guida nella definizione di una strategia comune, con norme condivise sulla sicurezza informatica, strumenti comuni per contrastare la disinformazione — tra cui un sistema europeo di certificazione delle notizie — e meccanismi di protezione coordinata delle infrastrutture critiche. Viene inoltre richiesto di istituire un meccanismo permanente di monitoraggio delle minacce ibride e un centro operativo europeo in grado di supportare gli Stati membri. Il documento afferma che “cittadini consapevoli sono la nostra migliore difesa a lungo termine” e suggerisce investimenti in programmi di alfabetizzazione digitale.
Il non-paper presenta infine una considerazione sulla rapidità con cui dovrebbe avvenire questo cambiamento. Secondo il ministro, la questione non riguarda “cosa dobbiamo fare”, ma la “velocità” con cui è necessario passare dalla postura attuale a una postura difensiva proattiva, ritenuta essenziale per ridurre gli spazi operativi degli attori ostili.