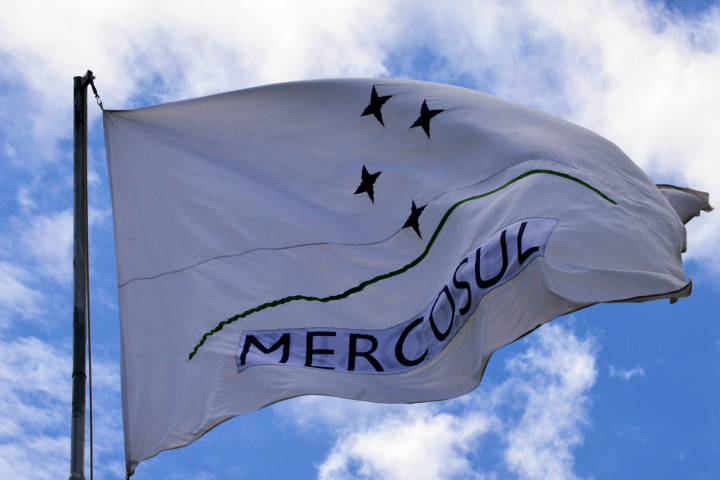Roma ha rimesso l’Albania al centro della propria politica balcanica con un’operazione molto più densa di quanto lasci intendere il cerimoniale: sedici accordi firmati in poche ore, cooperazione allargata a sicurezza, difesa, energia e un asse politico dichiarato apertamente da Giorgia Meloni ed Edi Rama. L’incontro di Villa Pamphilj sancisce un allineamento operativo che supera le formalità diplomatiche e indica la volontà dei due governi di consolidare un asse stabile in un quadrante europeo in piena competizione.
Roma riallinea il dossier Balcani
Il formato scelto per il primo vertice intergovernativo italo-albanese è stato il primo indicatore delle ambizioni in gioco. Niente riunione ristretta e poi conferenza stampa rituale, ma una plenaria in italiano, senza interpreti, con una ventina tra ministri e sottosegretari schierati sui due lati del tavolo. Meloni ha parlato di “giornata storica”, Rama le ha restituito l’immagine definendola “la grande sorella d’Italia”: una scelta di parole che mostra come entrambi abbiano voluto rimarcare la natura politica del vertice, ben oltre la routine istituzionale.
L’Albania arriva a Roma con l’obiettivo di consolidare il proprio partner principale nell’Unione, in una fase in cui deve reggere insieme tre tensioni: la pressione interna su riforme ancora incomplete, il controllo di attori esterni sempre più presenti nei Balcani e l’esigenza di non vedere slittare ancora l’orizzonte dell’adesione. L’Italia, dal canto suo, esce da anni in cui la presenza nella regione è stata discontinua e spesso lasciata alla sola dimensione economica, mentre altri Paesi – dalla Turchia a potenze extraeuropee – si sono inseriti in spazi lasciati scoperti.
Il vertice di Villa Pamphilj è stato preparato per mettere ordine: sedici testi che coprono difesa, sicurezza, energia, protezione civile, sanità, cultura, sviluppo economico, e che disciplinano in dettaglio procedure, canali amministrativi, linee di finanziamento. L’accordo intergovernativo G2G (Government-to-Government), in particolare, crea un circuito diretto tra ministeri omologhi, riducendo margini di inerzia e dispersione. L’operazione vuole trasformare un rapporto politico molto stretto in una struttura che resista ai cicli interni di entrambi i Paesi, vincolando le amministrazioni a un’agenda comune che va oltre la durata delle singole legislature.
Migrazione e sicurezza sotto esame
Il capitolo migratorio è quello che espone maggiormente i due governi, in patria e in Europa, ed è stato affrontato senza attenuare la posta in gioco. Il protocollo firmato nel 2023 ha portato alla costruzione di due centri in Albania sotto giurisdizione italiana, pensati per gestire parte delle procedure fuori dal territorio nazionale. Nel frattempo, però, il progetto è finito sotto la lente dei giudici italiani e della Corte di giustizia europea, con ricorsi che ne hanno rallentato o sospeso l’attuazione.
Meloni ha usato il vertice per ribadire la linea: il protocollo “metteva in campo un meccanismo innovativo che oggi trova interesse e riconoscimento da parte di molti altri Stati dell’Unione europea”, e “in molti hanno lavorato per frenarlo o per bloccarlo, ma noi siamo determinati ad andare avanti”. Meloni ha precisato che “quando entrerà in vigore il patto di migrazione e asilo, i centri funzioneranno esattamente come avrebbero dovuto funzionare dall’inizio” e “ciascuno si assumerà le proprie responsabilità” per i due anni persi.
Rama non si è smarcato, anzi ha rafforzato la scelta: “Lo rifarei cento volte con l’Italia. Con altri Paesi mai”, ha detto, aggiungendo che “se non sono l’Italia, non possono chiedere all’Albania tutto quello che gli viene in mente. Solo l’Italia può”. Questo scambio fissa un punto: l’Albania accetta di esporsi su un tema internamente sensibile, ma solo perché considera Roma un interlocutore stabile e perché si aspetta che il ritorno politico ed europeo compensi i rischi.
Intorno al protocollo, il pacchetto sicurezza chiude altri fronti: memorandum tra i ministeri dell’Interno per il contrasto al traffico di droga, accordo di cooperazione tra i ministeri della Difesa, intesa tecnica per la consegna di due pattugliatori alla Guardia Costiera albanese, sostegno alle capacità della protezione civile. L’obiettivo è restringere gli spazi alle reti criminali che usano l’Adriatico come corridoio, rafforzando controlli, scambio informativo e presenza marittima. Qui l’interesse è davvero simmetrico: l’Italia mira a ridurre la pressione su porti e coste; l’Albania ottiene mezzi, formazione e copertura politica che da sola faticherebbe a garantire.
Dalla difesa all’energia: cosa cambia sul terreno
Se migrazione e sicurezza sono la parte più esposta, il resto del pacchetto dà la misura di quanto i due governi puntino a costruire una cooperazione materiale, fatta di infrastrutture, investimenti e capacità amministrative. In ambito difesa, l’accordo tra i ministeri codifica una collaborazione che finora era rimasta in gran parte confinata al livello Nato e la estende a programmi di addestramento, scambio di informazioni e possibili partecipazioni dell’industria italiana alla modernizzazione dello strumento militare albanese. Sul fronte marittimo, i due pattugliatori destinati alla Guardia Costiera di Tirana rientrano in una strategia che vuole rendere più sorvegliato e prevedibile il bacino adriatico, collegando strettamente la capacità albanese di controllo alle esigenze di sicurezza italiane. In parallelo, gli accordi in materia di protezione civile prevedono crediti e donazioni della Cooperazione italiana allo sviluppo per dotare l’Albania di sistemi di risposta più efficaci a incendi, alluvioni, emergenze sismiche, con programmi di formazione mirati. Sul versante energia e sviluppo economico, l’insieme delle intese punta a valorizzare il ruolo dell’Albania come snodo nel quadrante adriatico: cooperazione su infrastrutture energetiche, rinnovabili, eventuali interconnessioni e progetti che interessano direttamente il tessuto imprenditoriale italiano già presente nel Paese. In sanità e cultura vengono aggiornati e ampliati protocolli che permettono scambi di personale, programmi congiunti e investimenti puntuali, con l’obiettivo di agganciare la crescita albanese a filiere italiane, anziché lasciarla a operatori extraeuropei più aggressivi. Nel complesso, questi sedici accordi delineano un quadro in cui Roma si propone come partner prevalente per la modernizzazione di pezzi interi dell’apparato statale e infrastrutturale albanese, mentre Tirana accetta di allineare standard, regolazioni e priorità in modo coerente con quelli italiani e, per estensione, con quelli europei.
I sedici accordi e la loro funzione operativa
Il pacchetto comprende strumenti eterogenei ma complementari, pensati per coprire ambiti amministrativi, infrastrutturali, energetici, industriali e culturali. La logica è rendere stabile il coordinamento bilaterale e dotare l’Albania di capacità tecniche che richiedono risorse e competenze che da sola non può garantire. Nel dettaglio, gli accordi firmati sono:
- Quadro intergovernativo G2G (Government-to-Government) per collegare in modo stabile le amministrazioni centrali dei due Paesi.
- Memorandum sulla cybersicurezza tra i ministeri degli Esteri.
- Credito d’aiuto alla Protezione Civile albanese per infrastrutture e mezzi.
- Accordo a dono per la Protezione Civile, finanziato dalla Cooperazione italiana.
- Accordo a dono per il settore neonatale nelle strutture sanitarie albanesi.
- Memorandum tra i ministeri dell’Interno per il contrasto al traffico di droga.
- Accordo di cooperazione tra i ministeri della Difesa su addestramento e interoperabilità.
- Memorandum culturale tra il MAXXI e la Galleria Nazionale d’Arte dell’Albania.
- Protocollo operativo tra le Protezioni Civili di Italia e Albania.
- Dichiarazione d’intenti Italia–Albania–AICS per la gestione coordinata degli interventi sul territorio albanese.
- Intesa tecnica per la consegna di due pattugliatori alla Guardia Costiera albanese.
- Credito d’aiuto per la rete elettrica del nord Albania, collegato alla ricostruzione post-terremoto 2019.
- Memorandum tecnico tra CDP e il Ministero delle Finanze albanese su progetti di investimento.
- Accordo tra SIMEST e AIDA per il sostegno alle PMI albanesi.
- Memorandum Fincantieri – Kayo per una futura joint-venture nei cantieri navali di Pashaliman.
- Memorandum Leonardo – Kayo per la cooperazione industriale nel settore della difesa.
Nel complesso, questo blocco di accordi crea un’infrastruttura amministrativa e tecnica più solida rispetto al passato: da un lato consente all’Italia di operare con continuità in settori strategici dell’apparato pubblico albanese, dall’altro offre a Tirana accesso a risorse, standard e tecnologie che difficilmente otterrebbe con la stessa rapidità da altri partner europei.
La posta in gioco oltre il bilaterale
Il vertice di Villa Pamphilj va letto anche come un messaggio diretto a Bruxelles. Rama ha legato esplicitamente il futuro dell’adesione albanese all’Italia, indicando il 2028 come anno in cui, “quando Giorgia sarà nella doppia veste di presidente del Consiglio italiano e di quello europeo”, potranno partire i negoziati politici per completare il percorso. Non si è fermato lì: ha dichiarato che l’Albania è pronta a “non utilizzare né il veto né il voto” nelle dinamiche interne dell’Ue e a essere rappresentata dal commissario europeo italiano, perché “sarebbe troppo avere due commissari europei per lo stesso Paese, perché siamo lo stesso Paese”. Sono formule che colpiscono per radicalità e che puntano a rafforzare l’idea di un legame quasi organico con Roma.
Meloni, dal canto suo, ha ribadito che sull’ingresso dei Balcani occidentali l’Italia è “tra le nazioni capofila” e che non si tratta di un semplice allargamento ma di una “riunificazione dell’Europa”. Dietro le parole ci sono passaggi concreti: per arrivare al traguardo evocato da Rama, Tirana deve affrontare la parte più dura dell’acquis, dalla giustizia agli appalti pubblici, dalla concorrenza alla tutela ambientale, fino alla riorganizzazione della pubblica amministrazione. Gli strumenti varati a Villa Pamphilj dovrebbero servire anche a questo: fornire assistenza tecnica, creare canali stabili tra strutture italiane e albanesi, accompagnare l’adeguamento normativo e operativo ai requisiti Ue.
In chiusura di conferenza stampa, il premier albanese ha richiamato episodi storici – la mancata consegna degli ebrei ai nazisti, la missione Arcobaleno, un film in preparazione su questi temi – per ribadire la continuità del legame con l’Italia e per offrire una cornice identitaria al percorso europeo che rivendica. Il messaggio complessivo è lineare: l’Albania mette sul piatto lealtà politica e disponibilità a vincoli stringenti, l’Italia si impegna a spingerne l’ingresso nell’Unione e a sostenerne il rafforzamento interno attraverso canali bilaterali che, dopo questo vertice, sono più strutturati di quanto fossero solo pochi mesi fa.