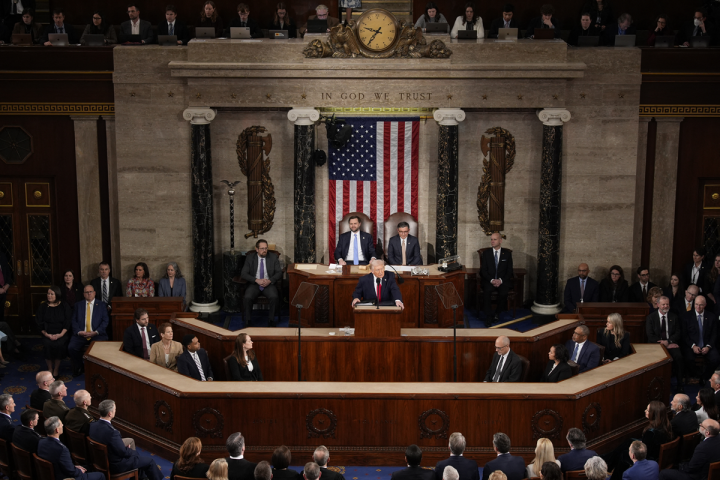In vista delle elezioni europee, il Censis ha analizzato i dati delle 242 regioni che compongono i 27 Paesi membri che saranno chiamati dal 6 al 9 giugno a scegliere il futuro dell’Europa. Negli ultimi anni, però, diversi mutamenti hanno reso l’Unione europea diversa rispetto al passato. Il progressivo ridimensionamento del peso demografico ed economico del continente europeo sul piano internazionale è il primo grande mutamento. A questo però fa seguito un declassamento sociale iniziato a 15 anni fa.
Il Censis, nel rapporto “Lo stato dell’Unione. Geografia sociale dell’Europa al voto”, riporta che un cittadino su tre, cioè il 34% della popolazione europea (150 milioni di cittadini) ha visto ridursi i propri livelli reddituali. Sono coloro i quali vivono in province periferiche rispetto agli assi produttivi dell’Europa e, a causa di questo inesorabile scivolamento, manifestano di conseguenza il profondo “malessere dei perdenti, che li porta ad allontanarsi anche dal cuore politico europeo”, scrive l’istituto.
Ma, a pesare nel contesto europeo ci sono anche: le forti disomogeneità territoriali persistenti all’interno dei singoli Stati, il fallimento delle politiche di coesione e l’elevato tasso di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee e la crescente tendenza all’astensionismo elettorale. Ma vediamo come sta cambiando l’Europa.
Il calo demografico europeo
L’Unione europea si è ridotta, demograficamente ed economicamente. Il suo potere ha visto nel corso degli ultimi 15 anni un calo della quota del Pil mondiale pari al -3,2%. Nel 2007, infatti, il totale era pari al 17,7%. Il ridursi della percentuale ha portato un vantaggio ad alcune altre aree del pianeta, soprattutto dei Paesi asiatici.
Il motivo di questo calo economico è dovuto alla riduzione della popolazione che 15 anni fa era pari al 6,5% della popolazione mondiale, mentre oggi è pari al 5,6% di tutti gli abitanti del pianeta. In aggiunta, le proiezioni demografiche relative al continente europeo, sempre più anziano e sempre più piccolo, attestano che la popolazione dell’Unione europea scenderà dagli attuali 449 milioni di abitanti a 448 milioni nel 2050, per poi ridursi ancora a 429 milioni nel 2075 (-4,3% rispetto a oggi).
La previsione in questo senso è che nel 2075 la sola Nigeria conterà una popolazione superiore a quella dell’interna Unione europea: 491 milioni di abitanti. Non a caso si prevede che sarà la quinta economia del mondo, dopo Cina, India, Usa e Indonesia.
Il declassamento sociale
Variazione negativa del reddito disponibile netto pro capite. Questo è la tendenza che si sta verificando negli ultimi 15 anni, in 75 regioni e province Ue. Il fenomeno ha coinvolto 151 milioni di cittadini (pari al 34% della popolazione europea e corrispondenti a 121 milioni di elettori), che hanno subito una flessione del tenore di vita familiare. E che si recheranno (eventualmente) alle urne “con un fardello sulle spalle: la percezione di un tradimento della promessa di miglioramento delle proprie condizioni, essendo stati soggetti a processi di divergenza anziché di convergenza, avendo vissuto un arretramento anziché un progresso”, scrive il Censis.
I territori del declassamento si trovano principalmente in Grecia, Italia e Spagna, ma anche in Francia, Austria, Ungheria, in porzioni del Portogallo, del Belgio e della Germania. I dati più preoccupanti si registrano nell’Attica in Grecia (con una riduzione del reddito pro capite rispetto al 2007 del 35,6%), ma anche in alcune regioni italiane: Lazio (-16,0%), Umbria (-14,7%), Provincia autonoma di Trento (-14,6%), Toscana (-14,6%). Con la grande crisi del 2008 è dunque cominciato il lungo ciclo del declassamento storico e sociale europeo, e sono molti i cittadini che si sono persi nelle pieghe della deindustrializzazione di tanti territori. Di tutti gli europei coinvolti, 4 su 10 sono italiani (il 39,1%).
Disuguaglianze territoriali
Calo demografico e declassamento sociale non riguardano tutti allo stesso modo. Persistono forti disomogeneità sociali nei diversi contesti territoriali all’interno dei singoli Stati, che possono minare la coesione delle comunità nazionali.
Ad esempio, in Irlanda si osserva una oscillazione vertiginosa tra i 36.556 euro di Pil pro capite del Northern and Western (il 55,4% in meno della media nazionale) e i 99.750 euro del Southern (il 21,8% in più della media nazionale). In Germania si va dal minimo di Lüneburg (29.261 euro di Pil pro capite) al massimo di Amburgo (69.065 euro). In Francia dal minimo della Lorena (26.340 euro) al massimo dell’Ile de France, la regione di Parigi (58.788 euro). In Polonia dal minimo di Lubelskie (19.291 euro) al massimo di Warszawski stołeczny, la regione della capitale Varsavia (57.953 euro). In Ungheria dal minimo di Észak-Magyarország (17.610 euro) al massimo della regione della capitale Budapest (56.788 euro). In Romania dal minimo del Nord-Est (16.512 euro) al massimo di Bucureşti Ilfov, la regione della capitale Bucarest (63.624 euro). La regione irlandese con il Pil pro capite più alto dell’Unione europea registra un valore pari a sette volte quello della regione bulgara con, al contrario, il valore più basso della Ue.
Il caso italiano: rischio astensionismo
L’obiettivo della convergenza è quindi evidente che sia un traguardo mancato. Un fenomeno che, nello specifico, coinvolge in modo netto l’Italia. Si oscilla dal valore minimo del Pil pro capite della Calabria (-40,9% rispetto al dato medio nazionale) al valore massimo di Bolzano (+65,4% rispetto al dato medio nazionale). E sono sei le regioni italiane in cui ancora si misura un Pil pro capite (a parità di potere d’acquisto) inferiore alla soglia del 75% del valore medio europeo: Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Sardegna e Molise.
Nei 27 Stati membri si voterà dal 6 al 9 giugno per rinnovare gli organi dell’Unione europea. Il quadro generale non è incoraggiante. I fenomeni complessi rischiano che si vada verso quell’astensionismo sempre più preoccupante, il cui tasso nel 2019 si è attestato al 49,3% nella media dell’Unione europea, con un picco raggiunto in Slovacchia (75,3%), un valore minimo toccato in Belgio (11,5%) e l’Italia collocata poco sotto la media europea (45,5%).
“In Italia – specifica il Censis – la tendenza all’astensionismo elettorale, intensa e prolungata nel tempo, mostra dati più allarmanti alle votazioni europee (il 45,5% di astenuti nel 2019) rispetto alle elezioni politiche (il 36,1% di astenuti nel 2022). L’astensionismo alle europee è aumentato costantemente: dal 14,3% del 1979 al 30,3% nel 1999, fino al 42,8% nel 2014 e al 45,5% del 2019. D’altra parte, oggi meno della metà dei cittadini europei ha fiducia nelle istituzioni europee”.
Il dato relativo all’Italia è in linea con la media europea: solo il 49% degli italiani ha fiducia nel Parlamento europeo, il 46% nella Commissione europea. In Slovenia appena il 37% dei cittadini si fida del Parlamento europeo e in Grecia solo il 33% della Commissione europea.
“La ridotta partecipazione elettorale e la scarsa fiducia nelle istituzioni europee si legano al lungo ciclo del declassamento storico e sociale che ha investito l’Europa a partire dal 2008, che si manifesta nel malessere dei perdenti e nella bruciante percezione di aver perso posizioni sul terreno del proprio benessere. E può insidiare gli stessi meccanismi di funzionamento delle democrazie liberali, se a giugno andrà a votare per il rinnovo del Parlamento europeo soltanto la metà circa degli elettori e se meno della metà dei cittadini europei ha fiducia nelle istituzioni comunitarie, nella loro capacità di offrire soluzioni apprezzabili e di fornire risposte efficaci”, ha concluso l’istituto di ricerca.