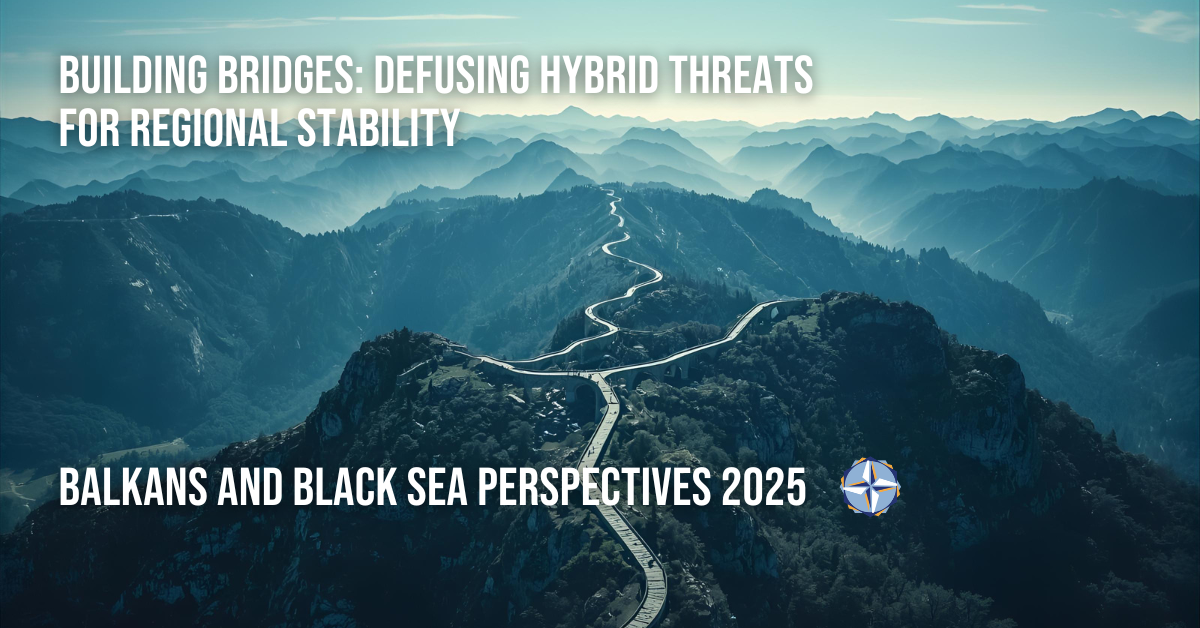“Non esistono più periferie per la sicurezza europea”. E tanto meno lo sono i Balcani Occidentali, quell’area che si estende dal Mare Adriatico al Mar Nero spesso trascurata dal dibattito generalista ma di importanza strategica fondamentale per il Vecchio Continente. In un periodo in cui tensioni politiche, instabilità, interferenze esterne e conflitti interni tornano a farsi sentire, la regione rischia di ridiventare quella ‘polveriera d’Europa’ per la quale è storicamente nota. Per approfondire la questione, la Nato Defense College Foundation (Ndcf) ha organizzato ieri a Roma una conferenza di alto livello, che ha ruotato attorno a diversi fili conduttori e spaziato dai problemi (instabilità, conflitti interni, minacce ibride) alle soluzioni (valori condivisi, sviluppo economico, allargamento, democrazia).
Un’area storicamente complessa
Le criticità sono note: tra questi, la recrudescenza di tensioni politiche e identitarie, le rinnovate spinte secessioniste in Bosnia ed Erzegovina, la persistente instabilità politica in Serbia e lo stallo tra Belgrado e Pristina sul Kosovo. “Segnali allarmanti di istituzioni indebolite, stanchezza democratica e vulnerabilità strutturale. Queste fragilità interne, amplificate da minacce ibride, disinformazione mirata, corruzione e criminalità organizzata, minano la fiducia dei cittadini. Guardando più a est, la guerra aggressiva della Russia contro l’Ucraina ha messo in evidenza l’importanza strategica del Mar Nero per la sicurezza euro-atlantica, per la sicurezza energetica europea e persino per quella alimentare. Inoltre, la regione rimane un crocevia vitale che collega l’Europa, l’Asia Centrale e il Mediterraneo Orientale”.
È stata Catherine Bourdès, direttrice Academic Plans, Policy & Engagement del Nato Defense College, dopo i saluti di Alessandro Minuto-Rizzo, presidente della Nato Defense College Foundation, a sottolineare in apertura dei lavori il ruolo strategico dei Balcani Occidentali. Bourdès ha aggiunto: “Non sono più aree marginali, ma sfide alla sicurezza e alla stabilità euro-atlantica”, a conferma che “non esistono più periferie” in tal senso. “Preservare questo spazio significa difendere la libertà di navigazione, la sovranità statale e la pace nel continente, oltre a proteggere i nostri valori condivisi: democrazia, diritti umani e stato di diritto”.
Unione europea e Nato— che mantiene due pilastri operativi nella regione — devono dunque accelerare la propria azione strategica, “e ravvivare le dinamiche di allargamento che riflettono la consapevolezza della necessità di mantenere questi Paesi legati al campo occidentale”, ha continuato Bourdès. La direzione è chiara, ha rimarcato Minuto-Rizzo: “L’obiettivo finale è la piena inclusione”. Un obiettivo reso urgente dal conflitto in Ucraina: “Fuori dai riflettori dei principali media, una crisi si sta preparando nei Balcani”.
Proprio in questi giorni, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è ‘in tour” nei Paesi nell’area per la ‘visita annuale’.
La presenza della Nato nella regione
“Balcani Occidentali sicuri significano maggiore sicurezza in tutta l’area euro-atlantica”, ha concordato Charlotte Hallengren, direttrice delle Operazioni presso il quartier generale Nato a Bruxelles. Dalla stagione delle guerre seguite alla dissoluzione della Jugoslavia di Tito, sono stati compiuti passi avanti verso una trasformazione democratica; in trent’anni l’Alleanza ha sostenuto sviluppo economico e sociale. Ma serve ancora “impegno operativo costante”, in particolare in Kosovo e Bosnia-Erzegovina: “Retorica divisiva, stagnazione politica e qualunque vuoto di sicurezza possono compromettere i progressi ottenuti”.
Hallengren ha ricordato i due capisaldi: KFOR, missione a guida Nato in Kosovo, e il sostegno dell’Alleanza alla missione EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina nell’ambito degli strumenti Berlin Plus. In Kosovo, dai 50 mila militari del 1999 si è scesi a circa 4.600, ha sottolineato l’esperta, ma episodi come Banjska/Zvečan mostrano la fragilità del quadro, aggravata delle campagne di disinformazione anti-occidentali di cui la KFOR è spesso bersaglio, “non solo false, ma pericolose per le truppe”.
La Nato “sostiene fermamente la sovranità e l’integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina” e non consentirà “vuoti di sicurezza” nei Balcani Occidentali. Ma accanto alla presenza militare, l’Alleanza rafforza anche il capacity building delle istituzioni locali (crisis management, cyber-difesa, antiterrorismo), “pilastro dell’atunomia”. Tuttavia, “una pace duratura non verrà dalle nostre truppe sul campo, ma da soluzioni politiche coraggiose e costruttive”, ha concluso Hellengren: per questo la Nato sostiene pienamente la normalizzazione tra Belgrado e Pristina guidata dall’Ue”.
Gli Accordi di Dayton
Uno dei perni dell’instabilità resta la Bosnia-Erzegovina, definita da Carl Bildt — già premier e ministro degli Esteri svedese — “una mini-Jugoslavia”. Impossibile parlarne senza richiamare i Dayton Peace Accords, alla cui realizzazione Bildt partecipò. Gli accordi, firmati nel dicembre 1995 a Parigi dopo i negoziati nella base di Wright-Patterson (Dayton, Ohio), posero fine alla guerra in Bosnia-Erzegovina, confermando uno Stato sovrano composto da due entità (Federazione di Bosnia ed Erzegovina e Republika Srpska). Definirono confini interni, ritiro delle forze e dispiegamento della forza internazionale IFOR, poi SFOR, a guida Nato. Introdussero anche una Costituzione bosniaca allegata all’accordo, fondata su un fragile equilibrio etnico-istituzionale che prevede una presidenza a rotazione tra tre persone.
“Il merito del 1995 fu allineare i principali attori internazionali”, ha osservato Bildt, “ma dedicammo più tempo a dividere la Bosnia (gli eserciti) che a riunirla”. A trent’anni di distanza, il Paese “funziona in qualche modo, ma potrebbe funzionare meglio”, collocandosi a metà tra “il fallimento completo che è Cipro” e il “Belgio, che è come Mostar, ma funziona perché ha istituzioni in qualche modo più forti”.
L’elemento centrale di preoccupazione, per l’ex premier svedese, è che “non solo in Bosnia, ma in generale nei Balcani, i giovani se ne stanno andando. La Bosnia era di 4,5/5 milioni di persone, ora è di 3,5 o qualcosa del genere”, mentre occorre “dare una sorta di fiducia nel futuro del Paese ai giovani in modo che restino e investano nel futuro lì”.
“Il rischio più grande è la stagnazione: crescita modesta, integrazione economica insufficiente, shock politici che complicano i processi. “Le cose non stanno andando così male, l’economia bosniaca è più o meno 2%. La Serbia sta andando bene, ma le differenze possono essere superate solo dall’integrazione econimica, che può essere favorita dall’integrazione europea”, ha detto ancora Bildt, dicendosi invece preoccupato per “il nord in Kosovo e l’incapacità di progredire nell’attuazione degli accordi” esistenti e “per lo stallo con la Macedonia del Nord”.
Sul pericolo dato dalla parte settentrionale del Kosovo è d’accordo Peter Sørensen, special representative dell’Ue per il Dialogo Belgrado-Pristina e per gli Affari regionali dei Balcani occidentali presso lo European External Action Service: “Ora aspettiamo fino al 1° novembre per vedere se i sindaci vengono di nuovo insediati. Se ciò accade, siamo di nuovo sulla buona strada con la gestione completa del Kosovo come è stato concordato dalle parti”.
L’allargamento
L’allargamento dell’Ue, strategicamente rilevante, è un tema su cui l’Unione va a rilento: dopo l’adesione della Croazia (2013), si è fatto poco, erodendo prezioso soft power, ha osservato Bildt. Alcuni Paesi sono avanti (Albania, Montenegro), altri restano bloccati da nodi irrisolti (il Kosovo non è riconosciuto da tutti gli Stati Ue/Onu; la Serbia ristagna nei negoziati). Paradossalmente, ha segnalato l’ex premier svedese, “una nuova spinta è venuta dall’invasione russa dell’Ucraina, che ha portato le capitali a cambiare opinione, come nel caso della Francia”, al fine di creare stabilità nell’est Europa. Bildt però ha avvisato: “Il nostro motto in Montenegro è ’28 entro il 28′, ma senza quella spinta da Bruxelles, non succede”.
Vessela Tcherneva, Deputy Director dello European Council on Foreign Relations a Sofia, ha chiarito: “Non è che i Balcani esploderanno domani. La storia lì è davvero sulla demografia, sullo sviluppo economico, è, tra l’altro, anche sulla democrazia, perché più si disilludono dalle loro prospettive di entrare nell’Ue, meno diventa probabile per i riformisti in quei Paesi guadagnare la fiducia del pubblico”. “Dobbiamo stare molto attenti nel calcolare cosa possiamo offrire loro. Una sorta di partenariato privilegiato? Accordi di sicurezza speciali per coloro che non sono nella Nato? Andare avanti alla cieca, come abbiamo fatto negli ultimi 10 anni o più, non è più sufficiente”, ha aggiunto.
Andrea Romussi, capo ufficio Nato della Farnesina, ha ricordato che “i Balcani Occidentali e la regione del Mar Nero, e cito dal paragrafo 45 dell’ultimo Concetto Strategico, sono di importanza strategica per l’Alleanza”. Eppure, come ha sottolineato Lara Jakes, corrispondente esteri a Roma del New York Times aprendo il panel dedicato alla strategia della Nato nei Balcani Occidentali, questa regione “non ha meritato nemmeno una menzione nel comunicato del vertice dei leader G7 di giugno all’Aja”, mentre i colloqui di adesione all’Ue sono ancora in corso, come da anni.
D’altronde l’allargamento passa per il nodo Serbia, con il rischio che si facciano passi indietro come in Ucraina, che, come sottolineato da Jakes, “voleva diventare più occidentale” e Mosca è intervenuta. Tcherneva ha spiegato che la Serbia è sempre stata considerata come il Paese “che produrrà l’allargamento per tutta la regione perché ha questo ruolo molto speciale per tutti i Balcani Occidentali e anche perché una volta che hai la Serbia dentro, puoi anche far entrare tutti gli altri, incluso il Kosovo”. Anche se si può fare una logica inversa e pensare che “se il Montenegro entra, diventerà chiaro anche per i serbi che hanno una possibilità e ciò potrebbe cambiare l’ambizione del Paese, perché sfortunatamente attualmente solo il 30% dei serbi sostiene l’Ue”.
Lana Parlich, membro del parlamento della Federazione di Bosnia-Erzegovina, ha spiegato: “Il percorso Nato e il percorso Ue non hanno alternative. E’ molto importante avere Althea e le forze Eufor in Bosnia-Erzegovina, non solo per non avere il vuoto di sicurezza, ma anche il vuoto politico, perché sta arrivando anche qui l’influenza russa e cinese”.
Fattori esterni di instabilità: Russia, Cina
Come ricordato da Jakes, la Russia, storico fattore di instabilità in Serbia e nella Republika Srpska, sta ancora sfruttando il dominio energetico (ad esempio, a Bosnia-Erzegovina ha due raffinerie che sono entrambe di proprietà dei russi) e il patrocinio politico e seminando disinformazione nel resto della regione. Ma “non possiamo dimenticare il massiccio attacco informatico da parte dell’Iran e di alcuni suoi agenti in Albania, che ha cercato di seminare sfiducia nelle istituzioni”. E ovviamente c’è anche la Cina, che “sta finanziando centinaia di progetti infrastrutturali, energetici e manifatturieri nei Balcani, con un investimento che un anno fa arrivava a 32 mld di euro, un terzo in Serbia”. Una cifra pari, ha sottolineato Zeynep Alemdar, director Foreign Policy Programme dell’EDAM, agli investimenti di tutti i 27 membri dell’Ue nel Paese. “La sicurezza economica dovrebbe entrare a pieno titolo nella cornice strategica euro-atlantica”, ha avvisato l’analista.
Il fattore Trump
Rimanendo sui fattori esterni, Alemdar ha fatto riferimento al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta velocemente scardinando la multipolarità, incoraggiando di conseguenza centri di potere alternativi. Preferendo negoziati bilaterali, sta inoltre indebolendo i quadri formali internazionale per la risoluzione dei conflitti. Il segretario di Stato Marco Rubio lo ha detto chiaro durante il suo discorso all’Onu: gli Usa difendono la sovranità e rifiutano il globalismo. Il risultato è che anche le potenze medie si stanno raggruppando in varie istituzioni. “Questa è la fine dell’ordine internazionale liberale e ci stiamo passando attraverso“. Dunque “non solo la credibilità degli Stati Uniti come stabilizzatore sia nei Balcani Occidentali che nel mondo si è ridotta o si è completamente erosa, ma anche le istituzioni si stanno indebolendo”.
Tcherneva ha notato che, al momento, i Balcani sembrano non essere ai vertici dell’agenda Usa, con il rischio di ulteriori spazi lasciati ad attori terzi. Valery Perry, Senior Associate presso il Democratization Policy Council a Berlino, ha aggiunto una riflessione: “Cos’è la Nato se non puoi contare sugli Stati Uniti come partner, se la posizione interna e internazionale degli Stati Uniti si sta erodendo al punto che non possiamo fidarci di un articolo 5”?
Le minacce ibride
Un’altra sfida attualissima è quella delle minacce ibride: disinformazione, interferenze elettorali, operazioni cibernetiche, strumentalizzazione di diaspore e flussi migratori. “I Balcani Occidentali sono uno dei principali teatri in cui si svolge oggi la competizione ibrida”, come anche in molti partner del Mediterraneo meridionale, ha sottolineato Romussi.
Alemdar, per la quale occorre definire meglio il perimetro di cosa siano tali minacce, “per non metterci dentro di tutto”, ha evidenziato una carenza nella cooperazione tra Nato e Ue nel contrastarle, carenza da colmare con urgenza. Tcherneva lo ha definito “un enorme punto cieco per l’Ue”.
Da alcune parti si parla di invocare l’art 5 della Nato anche in caso di disinformazione o manipolazione del sentimento pubblico, ma per Alemdar “ sarebbe un’esagerazione, ma d’altra parte abbiamo iniziato ad andare all’articolo quattro così spesso che non so se ne avremo bisogno”.
Solomon Passy, Founding President dell’Atlantic Club di Bulgaria, ha sottolineato che “in Bulgaria abbiamo circa 1.000 fake news russe al giorno”, e non è possibile “educare la popolazione all’autodifesa da 1.000 unità al giorno”.
Il risultato è grave: “Abbiamo in questo momento in Bulgaria tre gruppi parlamentari che riferiscono a Putin. Abbiamo gruppi parlamentari simili nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Slovacchia, ecc. Se Putin ha la maggioranza nel nostro parlamento, non ha bisogno di armi, non ha bisogno di armi nucleari, non ha bisogno di carri armati, non ha bisogno di nulla”. La soluzione potrebbe essere, e l’Atlantic Club of Bulgaria l’ha proposta, un algoritmo di ‘de-lavaggio’ del cervello, “molto semplice da formulare ma molto difficile e dispendioso da implementare”.
Un’altra riflessione è venuta da Alina Bârgăoanu, Dean nel College of Communication and Public Relations, National University of Political Studies and Public Administration a Bucarest. Secondo l’esperta, queste tattiche rischiano di passare sottogamba, perché si svolgono “al di sotto della soglia della guerra” e cercano di “strumentalizzare un ambiente informativo che è iperconnesso e che è molto, molto aperto”.
“Il fenomeno è interistituzionale, interdisciplinare ed è decisamente transnazionale e soffre dell’idea che alla fine del bias che quel tipo di guerra cognitiva sia una forma minore di guerra”. Un esempio calzante sono la Romania, dove l’anno scorso si sono dovute ripetere le presidenziali a causa di presunte interferenze russe, e la Moldova, dove la recente votazione, alla fine pro-europeista, ha visto in campo manipolazioni da parte di Mosca. “Non dovremmo trarre conclusioni troppo ottimistiche dai risultati delle elezioni, sperando che in qualche modo la guerra dell’informazione sia finita con un buon risultato”. Occorrerebbero invece “sforzi interdisciplinari ed interistituzionali e arrivare a approcci di rete integrati dall’alto verso il basso che siano decisamente transnazionali“.
Inoltre, la guerra cognitiva dovrebbe essere definita “come un grande attacco decisivo”, ma più “come processi sostenuti e cumulativi che cercano di iniettare determinate narrazioni nello spazio pubblico, costruire reti e comunità molto resilienti”, e dovrebbe essere inquadrata “meno come un problema di libertà d’espressione e più come un problema di organizzazione e di affordance algoritmiche“.
Perché, ha chiosato Passy, “non si può dire che propagandare che la terra è piatta sia libertà di parola. Questa è libertà di stupidità”.
Bârgăoanu ha poi sottolineato che il “kit di strumenti per combattere la guerra cognitiva” c’è (“misure legislative, misure non legislative, fact-checking, responsabilizzazione degli utenti, moderazione dei contenuti, responsabilizzazione dei giornalisti, rimozione dei contenuti”) ed è noto, ma “non è stato trasformato in una politica e non è finanziato”. Piuttosto, si è scelto di mettere in campo iniziative spot che non hanno portato risultati. “Un altro elefante nella stanza è la sovranità tecnologica dell’Unione Europea senza la quale ci lamenteremo sempre delle diverse campagne di influenza esterne”.
Romussi a tal proposito ha chiarito che in seno alla Nato “c’è una riflessione strategica sulla nostra capacità di decifrare, contenere e, se necessario, contrastare eventi di natura ibrida. Il nostro obiettivo è aumentare il costo opportunità di qualsiasi potenziale campagna ibrida russa”.
Perry ha invece affermato che “il modo migliore per resistere alle minacce ibride sia attraverso un ritorno alla sicurezza globale”, recuperando l’idea che “la pace democratica sia il modo migliore per garantire la crescita, lo sviluppo economico e la protezione dei diritti umani”.
Il ruolo della democrazia
E questo è un altro punto fondamentale, quello dei valori, messo in luce anche da Romussi: “Dovremmo mantenere alti i nostri standard democratici. Abbassarli non servirebbe al nostro interesse a lungo termine. Nel breve-medio termine, anche noi come famiglia euro-atlantica dovremmo lavorare non solo per una deterrenza e difesa più forti e capaci, ma per rafforzare la nostra resilienza nei confronti delle minacce multifattoriali provenienti dai nostri predatori strategici”.
Prlić lo ha ribadito: “La sicurezza non riguarda solo la minaccia militare, ma anche la costruzione della stabilità politica e la protezione dei valori democratici ed è per questo che la Nato deve essere presente nei Balcani Occidentali, perché non rappresenta solo i militari e la difesa, ma anche i valori in cui viviamo e crediamo”.
Anche Perry è stata chiara: “Se c’è una corsa al ribasso, l’Occidente perderà. Il miglior vantaggio competitivo che l’Unione Europea, che la Nato, con o senza gli Stati Uniti, ha è precisamente nei suoi valori. C’è una ragione per cui non vediamo persone a Sarajevo fare la fila per i visti per andare in Russia o in Cina. Stanno facendo la fila per andare in Europa perché è lì che vogliono che i loro figli vivano”.
“Mentre può sembrare che l’Occidente stia perdendo in questo momento, che i leader autocratici anti-democratici in tutto il mondo stiano davvero lavorando insieme, la domanda è: perché l’alternativa democratica non sta facendo lo stesso? Perché non c’è la stessa urgenza in termini di valori e narrativa e cosa lo sta impedendo”?
Un approccio “tutta la società”
In chiusura, Romussi ha tirato le fila del discorso, ricordando che l’Italia è attivamente impegnata nella regione, sostenendo fortemente il suo percorso di adesione all’Ue e attraverso un contributo chiave a KFOR (Paese leader per personale, 14 comandi dal 1999), oltre a essere guida della missione EULEX in Kosovo, e alla disponibilità ad assumere il comando di EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina nel 2026.
Tuttavia, ha chiarito, le sfide richiedono “un approccio ‘tutta la società’ in grado di gestire i conflitti in tutte le loro dimensioni, inclusa quella informativa, informativa, cognitiva”.
Se vogliamo davvero avere successo nel spingere il processo di integrazione euro-atlantica, “dobbiamo offrire una prospettiva chiaramente migliore rispetto ai nostri concorrenti strategici“, compiendo sforzi per “rafforzare la nostra sicurezza interna, anche attraverso il partenariato”, fortificando la resilienza delle società balcaniche e legando tale sforzo a riforme solide ed efficaci nei Paesi della regione. Perché “gli eserciti vincono le battaglie, i Paesi vincono le guerre“, ha concluso.