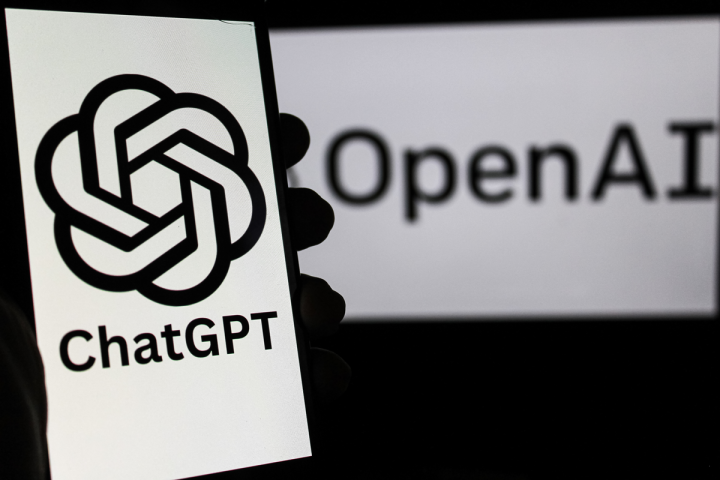Popolazione di 9,5 milioni, forza lavoro di 4,4 milioni, di cui 400.000 (il 12%) occupati nel settore high-tech. Oltre 7.000 startup, una ogni 1.400 abitanti, la densità più alta al mondo. 550 fondi di venture capital, 125 acceleratori, 23 incubatori, 18 uffici di trasferimento tecnologico, 10 università pubbliche che ci collaborano, come anche diversi ospedali. E 435 multinazionali con i relativi centri di ricerca e sviluppo posizionati in Israele al solo scopo di acquisire le realtà che sbocciano da questo hummus economico.
Eccolo, il volto di quella che l’imprenditore Jeremie Kletzkine definisce la “startup nation”: un ecosistema interconnesso e orientato alla creazione di valore. È il motore di uno dei Paesi più dinamici e tecnologicamente avanzati al mondo, perennemente sopra la media Ocse in termini di crescita del pil, in tempi di sviluppo e in tempi di recessione, di pace e di guerra. Un Paese in cui gli investimenti in ricerca e sviluppo sono pari al 5,6% del pil, 53% dell’export (pari al 20% del pil) è legato alla tecnologia e oltre il 90% delle startup sono business-to-business, offrono prodotti o servizi ad altre aziende.
Da questa galassia sono emerse aziende come Wiz, azienda di cybersicurezza sconosciuta ai più, che lo scorso marzo, nel suo quarto anno di vita, è stata acquisita da Alphabet, la holding di Google, per 32 miliardi di dollari: l’operazione più grande nella storia del colosso statunitense. E non è stato lo Stato a sussidiarne la crescita: in Israele è il settore privato che muove tutto, come spiega Kletzkine, imprenditore franco-israeliano e fondatore di una sequela di aziende di successo, a Eurofocus.
Denaro privato
“Nel 1990 il bilanciamento tra investimenti pubblici e privati era 50-50. Poi nel 1993 nacque lo Yozma Group”, un’iniziativa del governo israeliano per stimolare l’industria del venture capital nel Paese affiancando denaro pubblico a quello privato. Col tempo i capitali privati sono aumentati; oggi il rapporto è quasi 90-10, e Tel Aviv non intende modificare la formula. “Il governo non mette nemmeno uno shekel nei nuovi progetti se non ci sono anche investimenti privati. Sanno che l’ecosistema si abitua ai soldi pubblici e finisce per esserne penalizzato, perché i finanziamenti statali comportano vincoli, come la creazione di posti di lavoro, o la promozione di una certa regione”.
È miope calcolare il successo di un’impresa sulla base dell’occupazione che crea, anche se gli Sttati tendono a prediligere questo tipo di metrica. Una startup, ricorda Kletzkine, è un’azienda in cui non serve raddoppiare il numero di dipendenti per raddoppiare il fatturato. È un’impresa che scala, che riesce a crescere, produrre di più e fare più soldi, senza che in parallelo aumentino i costi dell’operazione. È un’azienda che può arrivare a valere miliardi di dollari, o centinaia di milioni, a seconda del settore e del mercato, “ma di sicuro non ti devi aspettare che generi subito ricavi o che abbia subito dei clienti, perché ha bisogno di sviluppare una tecnologia, di creare qualcosa di unico”.
Propensione al rischio
Il successo della “startup nation” dipende moltissimo da questa assenza di vincoli tradizionali, spiega l’imprenditore franco-israeliano. Alla base c’è la mentalità adatta a una nazione di startup: nelle aziende israeliane “il fallimento non è un problema e non compromette la carriera. Anche nelle grandi banche, se si spendono milioni su una soluzione software che poi fallisce, non si viene licenziati”. La propensione al rischio, l’assenza di gerarchie rigide, l’informalità, l’indipendenza e l’improvvisazione sono tratti comuni e incoraggiati, sottolinea: serve che dall’alto venga data la possibilità di correre dei rischi, di fallire, di sperimentare e dunque creare, “perché libertà significa innovazione. È la stessa cosa”.
L’altro grande differenziatore dell’economia israeliana è la sua forte internazionalizzazione. Nel 2024 sono confluiti 10,6 miliardi di dollari provenienti da capitali privati nelle startup tecnologiche israeliane. Per paragone, in Ue sono arrivati 6,1 miliardi – ma con un mix di denaro pubblico. Il 90% degli investimenti in Israele proviene dall’estero, e non esiste un vero mercato interno: la dimensione contenuta del Paese è un limite. “Ma proprio per questo le startup israeliane sono globali fin dal primo giorno, puntano al Nasdaq già dalla nascita”, sottolinea l’imprenditore, riferendosi alla borsa statunitense specializzata in società tecnologiche e ad alta crescita: per una startup oggi è “essenziale saper stare sul mercato globale” per poter attingere alle risorse necessarie per crescere.
La Boston del Medio Oriente…
Per percepire la vocazione internazionale di Israele non serve andare troppo distante. Basta guardare a sud, in direzione di Neom, la città futuristica immaginata dal principe saudita Mohammad bin Salman che sta sorgendo a partire dalla costa del Mar Rosso. E sta nascendo lì “perché si scommette su Israele e sulla normalizzazione dei rapporti”, processo interrotto dalla guerra in corso, spiega l’imprenditore, sottolineando che non “esiste New York senza Boston”: non si può creare un grande centro economico senza un polo vicino di università, centri di eccellenza, giovani talenti.
Sviluppi del genere sono il motivo per cui, anche al netto delle atrocità della guerra in corso (e con buona pace delle sorti del popolo palestinese agli occhi del mondo arabo), ai più alti livelli della politica israeliana e saudita si parla di affari. Un esercizio di realpolitik che può sembrare crudo e insensibile ma riflette la realtà di un angolo di mondo in cui le dinamiche tra Paesi impegnati a costruirsi un futuro provano ad andare oltre i limiti culturali imposti dalla pesante eredità della Storia.
… e la spinta dell’esercito
Infine, non va sottovalutato il ruolo economico delle Forze di difesa israeliane (Idf), da cui passa la quasi totalità della popolazione. “È centrale nella nostra vita civile, fa scouting di talenti, è il primo datore di lavoro in Israele, produce brevetti e segue interi cicli di sviluppo”. In Paesi meno sofisticati (e più autoritari) questa predominanza delle forze armate tende a essere caratteristica di un sistema più statico, votato alla sua conservazione, che asfissia l’innovazione e favorisce la corruzione. Non in Israele: “non è l’esercito a influenzare la cultura, è la cultura a influenzare l’esercito”, conclude Kletzkine.