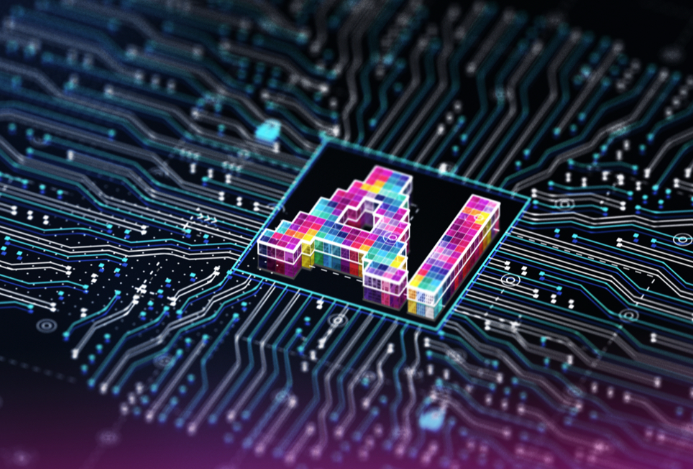La Cina ha presentato una proposta di governance globale per l’intelligenza artificiale. Il piano è stato annunciato dal premier Li Qiang al World Artificial Intelligence Conference (Waic), a pochi giorni dalla pubblicazione del piano strategico sull’Ai da parte degli Stati Uniti.
“Nel complesso, la governance globale dell’Ai è ancora frammentata. Esistono ampie differenze tra i Paesi, in particolare in termini di concetti normativi e regole istituzionali,” ha dichiarato Li Qiang nel suo discorso di apertura. “Dovremmo rafforzare il coordinamento per formare al più presto un quadro globale di governance dell’AI con un ampio consenso”.
Una proposta multilaterale in risposta alla frammentazione normativa globale
Il piano annunciato da Li Qiang durante la conferenza Waic è centrato sulla creazione di un sistema condiviso per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale. L’intervento del premier ha rilevato l’attuale assenza di un sistema coordinato e la presenza di approcci divergenti tra le principali economie.
“Se ci impegniamo in monopoli tecnologici, controlli e restrizioni, l’Ai diventerà un gioco esclusivo per un numero ristretto di Paesi e imprese”, ha affermato Li, senza menzionare esplicitamente gli Stati Uniti.
Il discorso è stato pronunciato pochi giorni dopo la pubblicazione da parte dell’amministrazione Trump di un piano che mira a eliminare “burocrazie inutili” e rafforzare il ruolo degli Stati Uniti come leader globale nel settore.
Il piano Ai degli Stati Uniti
L’‘America’s Ai Leadership Action Plan’, delinea -in 28 pagine- la visione degli Stati Uniti sul ruolo dell’intelligenza artificiale a livello nazionale e internazionale.
Il piano individua tre direttrici principali: consolidare la leadership statunitense nel settore, eliminare barriere normative ritenute “non necessarie” e rafforzare il primato americano nello sviluppo e nell’adozione di tecnologie Ai in settori chiave, tra cui difesa, sanità, trasporti, agricoltura e manifattura avanzata.
Uno dei passaggi centrali del documento è l’impegno a “rimuovere la burocrazia che ostacola l’innovazione”. In particolare, il piano prevede l’adozione di standard federali più snelli per l’approvazione di sistemi Ai, unificare le regole tra agenzie e Stati, e limitare gli obblighi di conformità per startup e pmi attive nel settore. Le agenzie federali sono invitate a “sostenere e non ostacolare lo sviluppo commerciale dell’intelligenza artificiale”.
In ambito commerciale, il piano propone una serie di incentivi fiscali per le aziende che investono in ricerca e sviluppo Ai sul territorio nazionale e prevede il rafforzamento dei fondi pubblici destinati a partenariati tra imprese e centri universitari. È stato annunciato un programma di matching pubblico-privato da 25 miliardi di dollari per progetti congiunti di formazione, hardware specializzato e sviluppo di modelli di linguaggio.
Il documento prevede anche misure per attrarre e trattenere talenti internazionali nel settore Ai, con un programma specifico per visti tecnici prioritari, la semplificazione delle procedure per la concessione della cittadinanza a ricercatori specializzati, e l’espansione dei fondi federali per borse di studio in Ai applicata.
A livello internazionale, l’amministrazione Trump ribadisce la necessità di “garantire che i principi democratici e occidentali guidino l’evoluzione delle tecnologie Ai”. Il documento definisce l’attuale competizione nel campo dell’intelligenza artificiale come una “sfida strategica globale” e afferma che la leadership Usa “è essenziale per preservare la sicurezza nazionale, la prosperità economica e la supremazia tecnologica a lungo termine”.
Il piano menziona esplicitamente l’importanza di limitare l’accesso a tecnologie Ai avanzate da parte di “attori che minacciano l’ordine internazionale basato sulle regole”. Pur senza nominare la Cina, il riferimento è reso esplicito dal contesto: il documento cita la necessità di controllare le esportazioni di chip, algoritmi di addestramento, set di dati critici e piattaforme di modellazione linguistica avanzata.
Infine, il piano annuncia la creazione di un ‘Ai International Council’ sotto la guida del Dipartimento di Stato, con l’obiettivo di costruire alleanze multilaterali per la definizione di standard tecnici e normativi. Il consiglio avrà anche il compito di monitorare gli sviluppi delle tecnologie Ai nei Paesi rivali e coordinare eventuali risposte diplomatiche o commerciali.
Le cifre della corsa cinese all’Ai
Dal canto suo, la Cina, secondo dati ufficiali, conta oltre 5.000 aziende attive nel settore dell’intelligenza artificiale. Ad aprile 2025, l’industria cinese dell’Ai aveva un valore stimato di 600 miliardi di yuan (circa 84 miliardi di dollari). Tra il 2013 e il 2023, le imprese pubbliche di venture capital hanno investito circa 209 miliardi di dollari in attività connesse all’intelligenza artificiale. Solo nel 2025, la spesa pubblica è destinata a superare i 400 miliardi di yuan (56 miliardi di dollari).
Per confronto, nel 2024 l’investimento privato in Ai negli Stati Uniti ha raggiunto i 109,1 miliardi di dollari, contro i 9,3 miliardi investiti dal settore privato cinese nello stesso periodo.
Sul piano della proprietà intellettuale, la Cina è in testa per numero di brevetti annuali registrati nel campo dell’Ai generativa dal 2017, secondo l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.
Nel primo semestre 2025, il modello R1 della startup cinese DeepSeek ha superato in performance modelli sviluppati da Meta e Anthropic. Il costo stimato dello sviluppo è stato di 5,6 milioni di dollari. Più recentemente, il modello Kimi K2 della startup Moonshot ha ottenuto risultati comparabili con quelli di OpenAi e Google, con costi inferiori. Secondo un’analisi di Morgan Stanley, il mercato cinese dell’intelligenza artificiale potrebbe generare un ritorno sugli investimenti del 52% entro il 2030.
L’Ue spettatrice nel duello Ai
Nel contesto del confronto tra Stati Uniti e Cina sull’intelligenza artificiale, l’Unione Europea si è distinta per il suo ruolo normativo, ma al World Artificial Intelligence Conference 2025 è emersa una significativa assenza politica. A Shanghai, l’Ue non ha partecipato con una delegazione istituzionale unitaria, mentre altri attori regionali come l’Asean (l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) hanno colto l’occasione per posizionarsi sulle questioni di governance.
L’Europa ha finora concentrato i suoi sforzi sull’approvazione dell’Ai Act, entrato in vigore nel 2024, con l’obiettivo di stabilire un quadro giuridico vincolante per l’uso e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Si tratta del primo strumento normativo di questo tipo adottato a livello internazionale, e rappresenta la principale leva con cui Bruxelles intende influenzare il dibattito globale.
Sul fronte industriale, però, la presenza europea resta limitata. Gli investimenti pubblici e privati complessivi nell’Ai si sono attestati poco sopra i 10 miliardi di euro nel 2024, secondo l’Ocse, un dato sensibilmente inferiore rispetto ai volumi messi in campo da Cina e Stati Uniti. Anche la partecipazione delle imprese europee alla Waic è stata circoscritta, con presenze individuali ma non coordinate a livello di sistema.
Negli ultimi mesi, la Commissione europea ha avviato interlocuzioni con partner asiatici, tra cui l’Asean e il Giappone, con l’obiettivo di definire principi condivisi per lo sviluppo dell’Ai. Si tratta tuttavia di iniziative ancora in fase esplorativa, che non sono state citate né formalizzate durante i lavori del Waic.
Bruxelles, da parte sua, non ha ancora espresso una posizione ufficiale sulla proposta di piano globale avanzata dal premier cinese Li Qiang. Mentre Stati Uniti e Cina strutturano visioni contrapposte per il futuro dell’intelligenza artificiale e ne fanno un asse centrale delle loro strategie geopolitiche, l’Unione Europea resta interlocutore normativo, ma privo di un’iniziativa diplomatica autonoma. In uno scenario che si sta rapidamente polarizzando, la sua assenza dal tavolo politico lascia temporaneamente scoperto un posto che altri, nel frattempo, si stanno già contendendo.