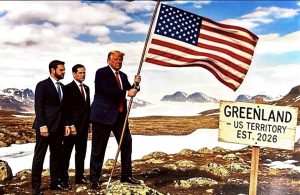Kubilius lancia il Comando spaziale europeo: “Solo l’unità può fermare Putin”
Alla European Space Conference 2026 Kubilius chiede una condivisione della sorveglianza spaziale e di accelerare su IRIS², che potrebbe entrare in servizio nel 2029