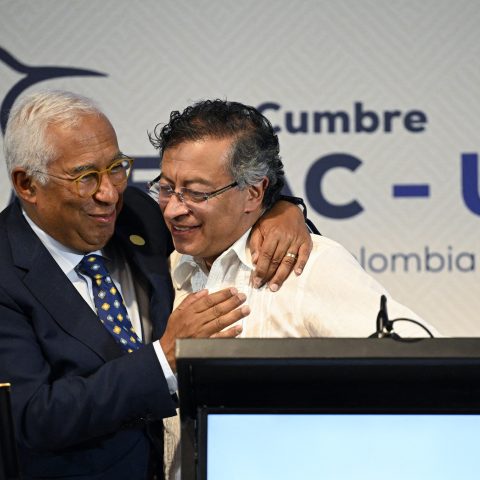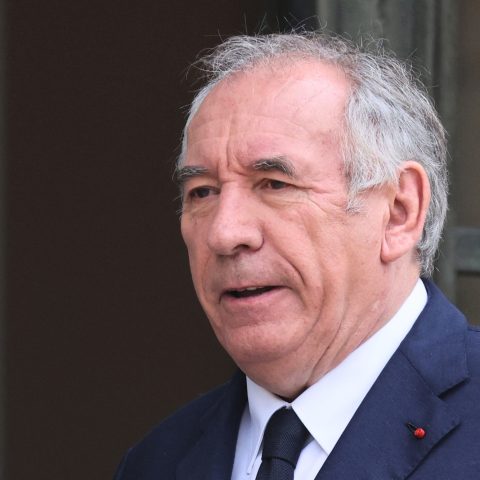Asset russi congelati per sostenere Kiev? Ai governi europei le alternative piacciono ancora meno
La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha presentato all'Europarlamento altre due opzioni: emettere debito comune o muoversi con prestiti bilaterali. In entrambi i casi, sarebbero le capitali a dover aprire i cordoni della borsa